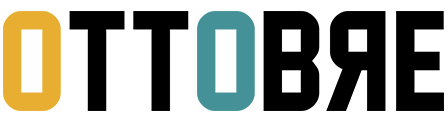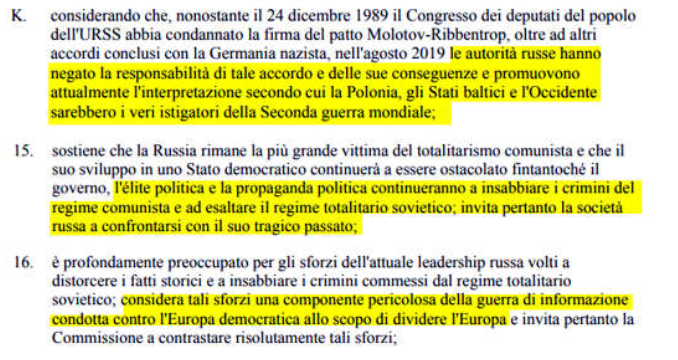Tucidide diceva, valutando positivamente Pericle che riusciva a blandire le eccitazioni degli ateniesi e le rimostranze contro il suo governo: “a parole era una democrazia, ma di fatto il governo del primo cittadino” (Storie, II, 65,10). Così si potrebbe valutare l’operato di Lukashenko dell’ultimo abbondante ventennio, almeno fino alle ultime proteste portate avanti dall’opposizione la quale è riuscita a mobilitare un numero rilevante di bielorussi contro il governo.
Nei più prosaici consessi della propaganda occidentale Lukashenko viene definito da anni “l’ultimo dittatore d’Europa”. E non importa se nei governi dei “primi cittadini” d’Occidente, nelle proteste antigovernative, si brutalizzino e storpino i manifestanti (come nel regime del primo cittadino Macron), o negli USA il tiro al bersaglio all’afroamericano sia ormai sport nazionale dei poliziotti, se nella Colombia filo-americana sanguinose repressioni si abbattono indiscriminatamente sui manifestanti nel totale silenzio dei suddetti media occidentali: tutti gli occhi di questi sinceri democratici sono puntati sull’ultimo dittatore d’Europa. Aleksandr Lukashenko, appunto. Ma per capire come il primo cittadino bielorusso abbia perso il suo talento di mediatore e la sua presa sulle masse è bene fare un breve excursus sulla storia politica bielorussa degli ultimi decenni.
LA LIQUIDAZIONE DELL’URSS E IL GRANDE BALZO ALL’INDIETRO
Nel 1988 l’attenzione distruttiva dei liquidatori dell’Unione Sovietica, con a capo il segretario del PCUS Gorbaciov, si era rivolta verso l’assetto istituzionale e politico degli organi della Repubblica. Nel dicembre di quell’anno il Soviet Supremo dell’URSS approvava la sua formale soppressione dando mandato al neo-nato “Congresso dei deputati del popolo” – una sorta di assemblea generale eletta a suffragio universale di 2250 membri divisi per categorie (organismi istituzionali, sindacati, cooperative, rappresentati di aziende, scienziati etc…) – di eleggere al proprio interno un’assemblea di 542 deputati chiamata analogamente “Soviet Supremo” che avrebbe dovuto fungere da parlamento permanente. Questo nuovo Soviet Supremo, sostanzialmente diverso da quello originale scaturito dalla costituzione del 1936 il quale contava prima della sua soppressione 1500 membri, andava ad abolire quel corpo collegiale permanente (che tra l’altro serviva anche da “Capo di Stato” della Repubblica) che era il Presidium del Soviet Supremo, sostituendolo con la figura del Presidente del Soviet Supremo: il capo dell’assemblea con funzione di Capo dello Stato.
È da notare come in questa nuova assemblea, per la prima volta, l’elemento operaio fu praticamente nullo mentre acquisivano sempre più rappresentanza dirigenti di aziende, intellettuali e altre categorie, persino i prelati. Inoltre, per la prima volta, i candidati indipendenti, presenti del resto sin dagli anni 30, non si presentavano più in blocco di coalizione con il PCUS. La borghesia nascente di quello che era stato il primo paese socialista della storia si liberava dei lacciouli istituzionali dell’Unione, e se “dopo uno studio approfondito dell’esperienza delle due rivoluzioni russe Lenin, ispirandosi alla teoria del marxismo, venne a concludere che la migliore forma politica della dittatura del proletariato non è la repubblica parlamentare democratica, ma la repubblica dei Soviet” (1) i deputati del Soviet Supremo gorbacioviano facevano della bara della Repubblica dei Soviet la culla della repubblica borghese.
Questa breve digressione sull’assetto istituzionale degli ultimi anni dell’URSS riveste la sua importanza nell’economia della trattazione per il fatto che le singole repubbliche sovietiche adottarono lo stesso organismo istituzionale, in scala, dell’Unione. Pertanto anche in esse vennero sostituiti i vecchi organismi con dei Soviet Supremi a mo’ di parlamenti nazionali e la figura del capo dell’assemblea di questi ultimi assumerà il ruolo di Capo di Stato nei governi delle nazioni indipendenti: era presidente del Soviet supremo russo Eltsin, di quello ucraino Kravchuk e Shushkevich di quello bielorusso, i tre che, nel dicembre del 1991, firmarono la dissoluzione dell’URSS e furono i primi presidenti delle loro nazioni indipendenti.
Nel marzo del 1990 le elezioni del Soviet Supremo bielorusso controriformato davano vita ad un’assemblea che vedeva in linea di massima la prevalenza della burocrazia sovietica liquidatrice insieme ad elementi ostili alle controriforme, che potremmo definire gli ultimi rappresentati del vecchio potere, e circa un dieci percento di deputati apertamente borghesi e indipendenti rispetto al Partito Comunista Bielorusso che facevano riferimento all’agguerrito, ancorché minoritario fra le masse, “Fronte Popolare Bielorusso, Adradzhennie” (BNF). Quest’ultimo era coacervo di tutti gli elementi anticomunisti e ultra-nazionalisti analogo ad altri movimenti civici, alcuni poi divenuti veri e propri partiti, che prendevano piede nelle repubbliche Baltiche (Sajudis in Lituania, Tautas in Lettonia, Rahvarinne in Estonia) e il Narodnyi Rukh in Ucraina, la maggior parte di questi dissoltisi una volta portata a termine la liquidazione delle repubbliche socialiste.
Il BNF – dall’ormai noto stendardo biancorosso degli stati fantoccio bielorussi creati dai tedeschi nei territori occupati nel 1918 e successivamente durante l’aggressione nazista dell’URSS – dopo le elezioni per il Soviet bielorusso poteva contare su una trentina di deputati su 360 e aveva come agenda politica l’indipendenza dall’Unione Sovietica e le classiche “riforme”. In campo politico economico, pretendeva la privatizzazione delle imprese statali, l’implementazione del capitalismo selvaggio e la liquidazione totale delle istituzioni sovietiche per sostituirle con un parlamento borghese in purezza. In campo culturale le altrettanto classiche “riforme” di abolizione della lingua russa, di criminalizzazione del passato sovietico e di glorificazione degli elementi reazionari e ultra-nazionalisti della storia del paese; un menù fisso divenuto poi di moda in tutte le ex-repubbliche sovietiche.
La pervicace azione di questo blocco nazionalista, che godeva naturalmente di enormi simpatie nei consessi occidentali, molto più che in patria, si scontrava con un’assemblea che procedeva per inerzia andando per lo più a ruota dei colpi di scena degli scoppiettanti vicini (Eltsin e baltici in testa) frustrando gli sforzi dei “sinceri democratici” del BNF. Nonostante ciò il BNF, sull’onda di avvenimenti analoghi in Russia, era riuscito a far adottare al Soviet bielorusso una formale dichiarazione di indipendenza, nel luglio del ’90. All’epoca dei fatti presidente di quell’assemblea era Nikolay Dementey, un comunista ostile al nuovo corso liquidatorio ed elegantemente defenestrato quando si accodò al famoso tentativo di “colpo di Stato” in URSS dell’agosto del 1991. Questo evento cruciale, quanto inutile, nella realtà dei fatti non fu un vero e proprio colpo di stato come narrato dalla storia sacra. Si trattò, piuttosto, come riferisce onestamente il liberale anticomunista Sergio Romano, di un tentativo da parte delle maggiori figure dello Stato sovietico, ormai sempre più esautorato, di reagire allo stato dei fatti e far valere le proprie legittime prerogative (2) di fronte ai veri golpisti – poi trasformati in eroi democratici insieme al loro sobrio e battagliero capitano Eltsin – i quali, contando sul dualismo di potere che si era formato grazie alle “progressive” riforme gorbacioviane, stavano spingendo sempre più verso la disgregazione totale dello Stato.
Pertanto le prodezze dei riformatori, così la storiografia prevalente chiama i liquidatori dell’URSS, avevano dato ossigeno al BNF che, nonostante lo zelo antisovietico, non riusciva a cavare un ragno dal buco in patria: gli erano ostili i colleghi “riformatori” ma più moderati che non gli consentivano di avanzare politicamente in assemblea, e gli erano ostili le masse che nel marzo del 1991 avevano votato per oltre l’83% (la percentuale più alta fra le repubbliche europee) per il mantenimento dell’Unione Sovietica. Il fallito tentativo di fermare il disfacimento dell’URSS dell’agosto del 1991 segnò de facto la fine dell’Unione, con i governi nazionali che questa volta, non solo formalmente, dichiaravano l’indipendenza. In Bielorussia il Primo Ministro Kebich si appuntò l’onore di tale atto “eroico”, sospendendo contestualmente l’attività dell’ormai morente Partito Comunista di governo, dopo le azioni analoghe di Russi, Ucraini etc. Nel frattempo al defenestrato Dementey succedeva Shuschkevich a capo dell’assemblea (e quindi dello Stato) denominata ancora Soviet. Shuschkevich era uno scienziato ed ebbe il compito di firmare il trapasso de jure dell’URSS insieme agli omologhi russi e ucraini nel dicembre del 1991 e la nascita dell’inutile sigla CSI (Comunità degli Stati Indipendenti).
Ad ogni modo, gli sforzi degli ultra-nazionalisti, nonostante questi eventi positivi per la loro causa, continuavano ad essere frustrati dal moderatismo del parlamento il quale, procedendo sempre per inerzia, non si decideva ad imbarcarsi in processi elettorali affrettati e a manovre di brutalizzazione economica della nuova Repubblica bielorussa. Questo anche per il fatto che le linee che si profilavano nei paesi vicini imponevano alla nuova assemblea una cautela che si rivelerà provvidenziale: in Lituania gli ex-membri del partito comunista, riciclatisi dopo la messa al bando nel “Partito Democratico del Lavoro”, avevano stravinto le elezioni nel 1992 doppiando con un 43% dei consensi gli ultra-nazionalisti del Sajudis (omologo del BNF) e in Russia iniziavano a delinearsi le prime insofferenze al nuovo disastroso corso economico eltsiniano.
La nuova borghesia bielorussa rappresentata a vario titolo nel Soviet, ad eccezione dei falchi del BNF che spingevano per la liquidazione totale, continuava a rimandare le elezioni della nuova assemblea nazionale borghese e del nuovo governo. Nonostante ciò, anche grazie alla pressione dei nazionalisti, il Parlamento approvò delle leggi di privatizzazione delle imprese statali, pur non integralmente, e l’introduzione della costituzione borghese che prevedeva la creazione della carica di Presidente della Repubblica come capo del governo al posto di quella di Primo ministro trasformando, quindi, la Bielorussia in Repubblica presidenziale. I nazionalisti riuscirono inoltre ad imporre per l’anno 1994 la calendarizzazione delle elezioni presidenziali. Queste si tennero, pertanto, come programmato, nel giugno del 1994 e videro la plateale affermazione del capo della commissione anti-corruzione del Soviet Bielorusso, Aleksandr Lukashenko, il quale raccolse il 45% delle preferenze al primo turno, superando abbondantemente il Primo Ministro uscente V. Kebich (17%), il leader del BNF, l’ultranazionalista cristiano Z. Pazniak (13%) e l’ex Presidente Shushkevich (10%), i comunisti, eredi del PCB messo al bando ma ricostuitisi come “Partito dei comunisti Bielorussi”, raccolsero il 4,5%. Al secondo turno addirittura Lukashenko venne eletto con uno schiacciante 80%. Iniziava con questa affermazione elettorale il governo, oggi più che ventennale e riconfermato secondo i termini di scadenza, di Lukashenko.
STRUTTURA E SVILUPPO ECONOMICO DELLA BIELORUSSIA POST SOVIETICA
Sin da subito il governo di Lukashenko si distinse dalla maggior parte dei regimi post-sovietici instaurati nelle altre ex-repubbliche socialiste. Innanzi tutto ripristinò tutti gli emblemi storici della Bielorussia sovietica (bandiera, emblema e feste nazionali: pur avendo opportunamente “espunto” le simbologie comuniste), frenò gli entusiasmi dei saccheggiatori delle proprietà statali e si mosse decisamente verso una cooperazione aperta con la Russia, tanto da firmare nel 1996 degli accordi di base per un’unione statale che, pur fra molte contraddizioni, passi avanti e indietro, è stata rinforzata nel 1999 – il che ha portato ad un forte partenariato economico, politico e militare fra le due nazioni – e procede tutt’ora verso prospettive, ancora non pienamente chiare, di una ulteriore integrazione.
Mentre in Russia e in Ucraina gli anni 90′ trascorsero nella devastazione sociale e umana più atroce, il governo a capitalismo di Stato di Lukashenko riuscì a risparmiare ai bielorussi le tragedie di paesi dove oligarchi, banditi politici e mafiosi veri e propri prosperavano nel paradiso del nuovo Far West. L’Ucraina era consumata da una guerra fra bande per il controllo dell’economia nazionale, con soggetti loschi come P. Lazarenko – trait-d’union con la malavita locale e le alte sfere politiche – che facevano la parte del leone spianando la strada al saccheggio e al potere politico di personaggi romanzeschi come la nota Timoshenko (3). La Bielorussia non subiva tali forze dilanianti, ed altrettanto gli veniva risparmiata la stagione mafiosa, terroristica e bellica che dovettero subire i cittadini russi grazie al nuovo corso inaugurato da Eltsin.
Così, in una condizione di maggiore stabilità politica, la Bielorussia poté imboccare un cammino socio-economico sostanzialmente diverso rispetto a quello dei suoi vicini. La Russia nel ’94 era in piena liquidazione e veniva trasformata da uno fra i più grandi paesi industriali al mondo in un importatore di beni di basso valore ed esportatore di materie prime. Oltre il 70% dei lavoratori delle medie e grandi imprese di stato (e il 100% delle piccole) erano divenuti salariati sotto padroni privati. Nuovi pescecani, autoctoni e stranieri, si facevano largo facendo saltare quella foglia di fico che erano le farsesche “distribuzioni” e/o vendite di quote delle aziende di stato ai dipendenti – il governo aveva prontamente legiferato affinché i nuovi oligarchi (di qualsiasi taglia) potessero ingurgitare tutto senza il ben che minimo ostacolo (4).
Lukashenko, dal canto suo, introduceva la Bielorussia nel capitalismo a passi molto lenti. Tutt’ora, benché la quota sia in lenta diminuzione, oltre il 50% dell’economia bielorussa è in mano statale, con grandi complessi industriali come la Minski Traktarny Zavod (MTZ) – fiore all’occhiello dell’industria trattoristica sovietica, e fra le più importanti aziende al mondo nel settore – che riesce a garantire ai suoi più di 30.000 lavoratori perfino delle cure sanitarie aziendali di primissimo livello, asili aziendali, campi estivi, centri culturali etc. (5). Il welfare bielorusso, garantito da questo sistema misto, ha consentito in generale ai bielorussi di avere delle condizioni di vita di gran lunga superiori rispetto ai propri vicini, di avere, per esempio, un reddito pro capite (a parità di potere d’acquisto; dati della Banca Mondiale) di 20 mila dollari, contro i circa la metà di Ucraina e Moldavia. Inoltre, a differenza di tutti gli altri e a livelli addirittura superiori ai paesi dell’Europa occidentale, il tasso di disuguaglianza in Bielorussia si è mantenuto a livelli bassissimi, solo lo 0,8% vive in una situazione di povertà (meno di 5,50$ al giorno) contro una media UE del 2,9%, o ad esempio il 4% della Lituania, il 2,7% di Russia e Polonia, il 6% in Ucraina (per non parlare di Moldavia, Armenia e Georgia, rispettivamente 16%, 50% e 43%).
Naturalmente questo non significa che l’economia Bielorussa scoppi di salute, una fetta larga di economia è in mano ai privati, inoltre l’ingresso, pur contingentato, di capitale straniero si fa sempre più rilevante, soprattutto nel settore hi-tech. La Bielorussia di recente ha costruito un parco a tema, una specie di Silicon Valley, per attrarre le grandi compagnie private grazie al basso costo di una manodopera altamente scolarizzata (elogiata anche da Pompeo nella sua ultima visita)(6). Ma se quest’ultimo settore potrebbe per certi versi rappresentare un volano di sviluppo tecnologico per il paese, lo stesso non si può dire della dipendenza dalle esportazioni di combustibili, un settore di enorme rilevanza per l’economia bielorussa e al centro di annose questioni di amore e odio con la Russia. Le esportazioni bielorusse si basano, infatti, per oltre il 20% (circa 8mld di $ su 33 totali) su petrolio raffinato e altri prodotti combustibili importati dalla Russia (la restante parte delle importazioni si basa su altri prodotti chimici, macchinari pesanti, prodotti agricoli e tessili)(7). Questo rapporto ricco di alti e bassi, e principale motivo di frizione fra i due paesi, è stato tendenzialmente improntato ad uno scambio privilegiato di questi prodotti da parte della Russia che vendeva alla Bielorussia – fino alla crisi del 2007 (8) – gas per 46$ per 1000 m/3 contro i 290$, per esempio della Germania. Questo anche in virtù dell’Unione Doganale fra i due paesi e dello stretto rapporto che prevede anche una forte cooperazione militare -benché non vi siano basi vi sono, però, istallazioni militari russe in Bielorussia, e d’altro canto la Bielorussia partecipa come fornitore al complesso militare-industriale russo (9).
La crisi del gas del 2006-2007 venne di fatto appianata con un aumento delle tariffe alla Bielorussia (fino a 100$ contro i 200$ richiesti da Gazprom) e tutta una serie di clausole che mettevano un freno ai “sussidi” che la Russia versava alla Bielorussia grazie alle corsie preferenziali sul prezzo del gas, e tuttavia non venne risolta del tutto, tanto da ripetersi ancor più duramente con la cosiddetta “manovra fiscale” varata dai russi la quale introduzione completa dovrebbe chiudersi nel 2024. Questa manovra prevede la graduale abolizione del dazio sull’esportazione del gas per le aziende russe e il contestuale aumento dell’imposta sull’estrazione, un meccanismo per sovvenzionare le proprie raffinerie petrolifere ad ovvio detrimento di quelle bielorusse.
Questa grossa perdita per l’economia bielorussa, già in atto ma potenzialmente ancora maggiore, è alla base degli atteggiamenti da taluni ritenuti fumantini, se non proprio schizofrenici, da parte di Lukashenko. Quest’ultimo, in realtà, a grande rischio, ha cercato di fare pressioni alla controparte russa paventando aperture ad occidente che in definitiva non avvantaggerebbero nessuno dei due ma avrebbero comunque la funzione pungolare il fratello maggiore – parte naturalmente forte del rapporto in atto – ad avere atteggiamenti meno dominanti nei confronti della Bielorussia. Insomma, un tentativo spericolato di salvaguardare l’indipendenza del paese, anche e proprio in virtù di quella Unione Statale che, benchè arenata, è sul tavolo da vent’anni e pur auspicata da entrambi, potrebbe risultare per la Bielorussia un’annessione senza indennità. A tal proposito l’anno scorso lo stesso Lukashenko ribadiva in un incontro: “cosa fare con l’Unione? Dobbiamo sederci a un tavolo e vedere cosa possiamo fare insieme. L’unione si può formare solo su un piano di parità. E’ un principio base di qualsiasi unione: nessuna base equa ― nessuna Unione. Altrimenti sarebbe un’annessione del debole da parte del più forte debole, o una incorporazione.” (10)
Questo stato di cose porta a chiarire anche molti aspetti della crisi attuale. La crisi economica che colpirebbe potenzialmente la Bielorussia dalla perdita delle “royalties” della raffinazione petrolifera porterebbe ad una progressiva insostenibilità del welfare che il sistema bielorusso riusciva tutto sommato a garantire ai propri cittadini e minerebbe la posizione stessa di Lukashenko che si troverebbe schiacciato fra due fuochi: l’avanzata della mai doma opposizione della borghesia liquidatrice interna appoggiata dall’imperialismo occidentale, e l’interesse russo ad avanzare le proprie pretese egemoniche sulla Bielorussia. Il condizionale, d’obbligo fino a qualche mese fa, non è più tale.
DIALETTICA POLITICA: IL PRESIDENTE, LE PROTESTE E I COMUNISTI
Prima di descrivere la situazione attuale, e dopo aver delineato le principali questioni dei rapporti russo-bielorussi, è bene delineare gli appetiti dell’opposizione interna e lo stato di quest’ultima negli ultimi due decenni. Negli anni successivi alla prima elezione di Lukashenko (1994) e all’approvazione referendaria delle modifiche alla Costituzione (1996) le opposizioni liberal-conservatrici raggruppate attorno al summenzionato Fronte Popolare Bielorusso (BNF), che tanta parte avevano giocato (pur avendo un bassissimo consenso popolare) nei primi anni dell’indipendenza, vissero un momento di disorganizzazione, dovuto anche a faide interne, che portarono verso la fine del decennio ad una scissione del partito. Ciò significò anche una relativa calma dalle pressioni esterne per Lukashenko e la Bielorussia, pressioni e interessi che inevitabilmente il BNF coagulava attorno a sé, tanto che le elezioni del 2001 si svolsero senza troppe tensioni, se non le solite accuse di irregolarità da parte delle potenze imperialiste che di là innanzi diventeranno una costante. Lukashenko vinse abbondantemente superando l’avversario Goncharik.
Tuttavia per le elezioni ancora successive, cioè quelle del 2006, la situazione mutò decisamente sul fronte anti-governativo. Già da un paio di anni, infatti, andava ricompattandosi un movimento di opposizione, carico dei vecchi arnesi ultra-nazionalisti sebbene ammantato nuovamente di afflati civico-democratici. La miccia che riaccese l’opposizione in Bielorussia fu il referendum del 2004 con il quale Lukashenko cercava di garantirsi un’estensione di mandato potendo correre per la terza volta consecutiva. La vittoria schiacciante in favore di Lukashenko, portò alle prime proteste post-elettorali, divenute successivamente rituali, e alla creazioni di movimenti “civici” come “Coalizione popolare 5 plus”, che raggruppava una serie di partiti di opposizione dal BNF, ai socialdemocratici agli ex-comunisti e si rifaceva ad una piattaforma precedete chiamata “Chartya-97”, creata appunto nel 1997, che scimmiottava un omonimo movimento anticomunista cecoslovacco di fine anni settanta (un’omonima e analoga piattaforma* verrà creata in Cina nel 2008 attorno al premio nobel filo-americano Liu Xiaobo). I consensi popolari che riscuotevano questi movimenti erano molto scarsi, ma sufficienti per mobilitare qualche migliaio di persone e accreditarsi agli occhi dell’imperialismo occidentale quale cavallo su cui puntare per successivi sommovimenti.
Questi si concretizzarono, come anticipato, al termine delle presidenziali del 2006 che videro di nuovo ampiamente trionfante Lukashenko contro il candidato dell’opposizione ultra-nazionalista Aleksander Milinkevich. Quest’ultimo coagulava nel “Fronte Democratico Unito di Bielorussia” tutte le piattaforme, movimenti e partiti sopramenzionati. Dopo le elezioni le opposizioni – capeggiate sul campo dal neo-nato movimento giovanile “Zubr”, un outlet della linea di “Otpor!” di Gene Sharp, teorico delle rivoluzioni colorate – imbastirono la prima ufficiale rivoluzione del genere in Bielorussia e la chiamarono, analogamente a quelle svolte nei paesi vicini, con il nome di un colore: il denim – “Rivoluzione dei Jeans”. La lezione delle rivoluzioni colorate degli altri paesi e la scarsa partecipazione popolare – al culmine riuscirono a mobilitare a malapena 40mila manifestanti, numeri irrisori se si pensa a quelli dei vicini, o soltanto a quelli mobilitati nella stessa Bielorussia in questi mesi (11) – risolsero il tentativo di cambio di regime in un fiasco. Tuttavia il dado era tratto, e da lì innanzi ogni elezione in Bielorussia divenne laboratorio di macchinazioni interne ed esterne che si riproposero quasi in copia carbone ad ogni tornata elettorale, sempre più stancamente (nel 2010 e nel 2015) fino ad arrivare alle elezioni dell’anno corrente, 2020.
Le proteste iniziate da fine maggio scorso e ampiamente scontate (12), ancora prima delle elezioni stesse, sono cronaca contemporanea. La crisi economica, della cui natura si è sopra accennato, unita a quella portata dal coronavirus (e le critiche all’atteggiamento riduzionista di Lukashenko) ha fornito la stura alla più grande ricomposizione delle opposizioni nazionaliste e liberal-conservatrici per tentare un ennesimo “scacco al re”. L’evento rituale per questa sorta di olimpiadi dell’opposizione erano naturalmente le elezioni presidenziali. Questa volta, per non sbagliare, i tentativi di destabilizzazione sono iniziati già prima dei risultati, ovviamente accusando le solite repressioni cieche che sarebbero state operate da Lukashenko contro i suoi oppositori politici, il che è anche parzialmente vero, tuttavia i media occidentali glissano sul fatto che la reazione preventiva degli apparati di sicurezza bielorussi sono in larga parte una risposta ai tentativi di colpi di mano preventivi – alla maidan – che secondo “autorevoli” testate, avrebbero costituito l’ennesimo movimento civico: “La rivoluzione delle ciabatte” (13).
Colpi di mano portati avanti da personaggi spregiudicati come il blogger ultra-nazionalista Serghei Tsikhanouski (una sorta di Navalny bielorusso), arrestato dalle autorità perchè trovato in possesso di quasi un milione di dollari in contanti e per aver aggredito la polizia. Altri personaggi meno farseschi ed anch’essi candidati alla presidenza erano i due candidati ultra-liberisti: Viktor Babariko, ex capo di Gazprom Bank, visto con simpatia da Mosca, e Valery Tsepkalo, il candidato presentabile di Washington. In ogni caso, dopo le forti tensioni pre-elettorali, le opposizioni si sono coagulate attorno alla moglie dell’incarcerato Tskikanouski, Svetlana Tsikhanouskaya, la quale, sconfitta da Lukashenko alle elezioni, ha recitato la parte del Guaidò in salsa bielorussa ma con meno pertinacia, tanto da emigrare nei paesi baltici, e – più per pressioni della propria parte che per convinzione personale – proclamarsi vincitrice, chiamando alla mobilitazione generale contro Lukashenko. Appelli alla mobilitazione che questa volta hanno colto maggiormente nel segno riuscendo a fare leva sulle insoddisfazioni popolari nei confronti del governo e, più in generale, sulla formale critica alla figura del presidente Lukashenko. Critica estetica, ormai, portata avanti lungamente dall’imperialismo occidentale che al presidente “eterno” simbolo di una borghesia nazional-paternalistica comunque garanzia di indipendenza, preferirebbero figuranti come il sanguinario servo della Nato Poroshenko o il giovane pupazzo Zelenski, che possano garantire all’imperialismo euro-atlantico l’asservimento totale di uno degli ultimi paesi indipendenti d’Europa.
In questo contesto non è nemmeno necessario confutare come la propaganda becera sulle terribili repressioni del regime siano in larghissima parte false ed esagerate quasi ridicole se paragonate alle terribili, queste sì reali, repressioni che avvengano negli USA, in Francia, in Colombia etc solo per citare gli ultimi casi; ma è bene tuttavia chiarire come le masse bielorusse sembra stiano interpretando la protesta. Se una larga parte dei manifestanti è composta principalmente da liberali, ultra-nazionalisti, persone che più o meno genuinamente cadono nelle ormai note trappole retoriche della libertà astratta, è anche vero che le opposizioni liquidatrici siano riuscite a coinvolgere, seppure in piccola misura, alcuni strati del proletariato.
La Bielorussia non è un paese socialista, Lukashenko è un leader, come già accennato, rappresentate della borghesia nazionale post-sovietica che purtuttavia è riuscito a frenare le pulsioni più disgregatrici e distruttrici tipiche dell’area. Il paragone che la stragrande maggioranza dei bielorussi può facilmente fare con i propri vicini – in primis gli ucraini, i quali vivono uno stato di devastazione sociale ed economica che certo i cittadini bielorussi non auspicano per sé – dimostra come una larga fetta di popolazione sia rimasta indifferente se non attivamente ostile ai richiami degli aspiranti maidanisti. Le manifestazioni a favore del governo e in generale la tenuta di quest’ultimo dimostrano come la maggioranza della società, pur silenziosa, non è pronta alla liquidazione totale dello Stato, nonostante alcune criticità del regime stesso. Gli stessi comunisti sia in patria che all’estero, pur mettendo in luce la reale natura borghese del governo, si rendono conto della necessità di evitare che forze reazionarie e liquidatrici prendano il sopravvento in Bielorussia, ottima la sintesi del segretario del Partito comunista operaio russo-PCUS, Melenchov, nel descrivere la situazione e i compiti dei comunisti:
Queste forze non possono perdonare a Lukašenko di non avere imboccato la via di Gaydar col metodo della «terapia d’urto», di non aver consentito una privatizzazione da rapina, né quelle riforme finanziarie antipopolari che in un attimo hanno fatto precipitare nella povertà la popolazione della Russia. Inoltre, Lukašenko ha garantito la salvaguardia della grande industria statale e dell’agricoltura, della regolamentazione statale, delle garanzie sociali, ecc.. Ciò detto, non nutriamo illusioni e comprendiamo come il modello costruito da Lukašenko sia comunque un modello capitalistico.” e più avanti, ” Il PCOR invita i lavoratori della Bielorussia a non consentire l’avvio e lo sviluppo del Maidan bielorusso secondo il modello di Kiev, ma allo stesso tempo a utilizzare la situazione di insoddisfazione di parte della società per i risultati delle elezioni per rafforzare le proprie forze di classe, per tenere riunioni nei reparti di fabbrica e nella produzione per sviluppare le proprie rivendicazioni nei confronti delle autorità. Ora è il momento per gli operai di avanzare la rivendicazione decisa di un cambiamento della legislazione del lavoro nell’interesse di tutti i lavoratori e del ripristino dell’età pensionabile sovietica, di organizzare scioperi a sostegno di queste richieste. (14)
Evitare, dunque, la svolta reazionaria, e allo stesso tempo lavorare per un accumulo delle forze della classe operaia. Sottolineare i limiti del capitalismo di Stato in Bielorussia, e le contraddizioni politiche ed economiche col quale esso si manifesta, deve essere uno stimolo progressivo verso il suo superamento in direzione del socialismo, non di certo verso la reazione ultra-capitalista dove vorrebbero gettare la nazione i cripto-fascisti, i liberali e i feticisti della democrazia formale. Paradigmatici a tal proposito gli appelli di chi conosce molto bene queste situazioni, per averle subite sulla propria pelle, come i lavoratori e i sindacati ucraini di Kharkov e Mariupol che si appellano ai lavoratori bielorussi:
“ci appelliamo ai lavoratori della Bielorussia, a non cedere alle false richieste di sciopero dei cosiddetti oppositori, che chiedono di non riconoscere i risultati delle elezioni presidenziali. Il loro obiettivo è la distruzione, nell’interesse delle società transnazionali che sono dietro le agitazioni, dei collettivi di lavoro, il sequestro e la privatizzazione delle imprese bielorusse al fine di dominare i mercati, i loro concorrenti e impadronirsi del paese.” (15)
Per tali ragioni, il supporto all’indipendenza della Bielorussia e al suo governo nazionale che, piaccia o meno, oggettivamente ne difende le prerogative, non può essere messo in discussione da posizioni “nénéiste” di settaria o dogmatica indifferenza, se non per giunta ostili. Per dirla con Mao: “sostenere tutto ciò contro cui il nemico combatte, e combattere contro tutto ciò che il nemico sostiene”.Il nemico in questo caso è senza ombra di dubbio l’imperialismo che dirige i suoi artigli e i suoi sordidi appetiti sulla Bielorussia e il suo popolo, per questo sostenere Lukashenko non deve essere un tabù per i comunisti, pur riconoscendone gli oggettivi limiti e le contraddizioni del suo governo. Giova citare il celebre passo, perfetto per descrivere la questione, dai Principi del leninismo di Stalin:
“La lotta dell’emiro afghano per l’indipendenza dell’Afghanistan è oggettivamente una lotta rivoluzionaria, malgrado il carattere monarchico delle concezioni dell’emiro e dei suoi seguaci, poiché essa indebolisce, disgrega, scalza l’imperialismo, mentre la lotta di certi «ultra» democratici e «socialisti», «rivoluzionari» e repubblicani dello stampo, ad esempio, di Kerenski e Tsereteli , Renaudel e Scheidemann, Cernov e Dan, Henderson e Clynes durante la guerra imperialista, era una lotta reazionaria, perché aveva come risultato di abbellire artificialmente, di consolidare, di far trionfare l’imperialismo. La lotta dei mercanti e degli intellettuali borghesi egiziani per l’indipendenza dell’Egitto è, per le stesse ragioni, una lotta oggettivamente rivoluzionaria, quantunque i capi del movimento nazionale egiziano siano borghesi per origine e appartenenza sociale e quantunque essi siano contro il socialismo, mentre la lotta del governo operaio inglese per mantenere la situazione di dipendenza dell’Egitto è, per le stesse ragioni, una lotta reazionaria, quantunque i membri di questo governo siano proletari per origine e appartenenza sociale e quantunque essi siano «per» il socialismo. E non parlo del movimento nazionale degli altri paesi coloniali e dipendenti, più grandi, come l’India e la Cina, ogni passo dei quali sulla via della loro liberazione, anche se contravviene alle esigenze della democrazia formale, è un colpo di maglio assestato all’imperialismo, ed è perciò incontestabilmente un passo rivoluzionario.” (16)
E certo il “primo cittadino” Lukashenko, è perfino meglio dell’emiro Afghano, in quanto contro di lui si schierano apertamente, pur mascherati da false e ipocrite fraseologie libertarie, gli elementi più reazionari e sciovinisti, nelle figure dei leader dell’opposizione, del capitalismo finanziario e dell’imperialismo.
(1) A.A.V.V., Storia del partito comunista bolscevico dell’URSS, Edizioni in Lingue estere, Mosca, 1948 pp.387
(2) S. Romano in Storia della Russia di Nicholas Riasanovsky, Bombiani, Milano, 2013, pp. 622
(3) Per approfondire la storia politica Ucraina di quel periodo fino ai prodromi di Maidan vedi Julija Timoshenko, la conquista dell’Ucraina, Teti Editore, Roma, 2016
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_94_49
(6) https://twitter.com/SecPompeo/status/1223702248913502209?s=20
(7) https://oec.world/en/profile/country/blr
(8) https://www.repubblica.it/2006/12/sezioni/esteri/gazprom-2/mosca-minsk/mosca-minsk.html
(9)https://www.analisidifesa.it/2019/05/mosca-e-minsk-tra-cooperazione-militare-e-tensioni-energetiche/
(11)https://www.heddels.com/2014/08/remembering-belaruss-denim-revolution/
(12) cfr. il sito anti-imperialista “Moon of Alabama” aveva ampiamente predetto, non che ci fosse molta sorpresa, come si sarebbero svolti i fatti: https://www.moonofalabama.org/2020/06/belarus-a-us-sponsored-color-revolution-is-underway.html
(14)https://www.lordinenuovo.it/2020/08/15/analisi-del-pcor-pcus-sugli-avvenimenti-bielorussi/