Con questo scritto di G. Carocci ci proponiamo di continuare per la rubrica “Storia” quel racconto che analizza i punti salienti dello sviluppo del capitalismo in Italia. Dopo il primo capitolo circa le origini dello sviluppo del capitalismo nell’Italia pre-unitaria, passiamo con l’ampliare lo sguardo alle questioni del capitalismo nell’Italia liberale post-unitaria e agli atteggiamenti della politica, e della borghesia, lungo quel torno di tempo che vede il passaggio della fase concorrenziale del capitalismo fino al primo sviluppo dei monopoli. Uno sviluppo che costituisce un retroterra fondamentale per comprendere le azioni della borghesia italiana e la consequenzialità dei suoi stretti rapporti col regime fascista, il quale si dimostrerà perfettamente organico alle esigenze politiche ed economiche della classe dominante.
L’INDUSTRIA NEGLI ANNI OTTANTA
Dopo il 1870 iniziò in tutti i paesi che oggi diremmo sviluppati o sulla via dello sviluppo quella marcata estensione degli interventi pubblici che, pur nata nei decenni precedenti, è tuttavia tipica dello stato contemporaneo. Le cause di questi interventi stavano nelle accentuate difficoltà che la borghesia al potere doveva affrontare: difficoltà di ordine economico per la “grande depressione”; difficoltà di ordine sociale per l’affermarsi del movimento operaio; difficoltà di ordine internazionale per la concorrenza economica e politica tra le potenze. Questo triplice ordine di difficoltà stimolò la concentrazione monopolistica, l’imperialismo, il protezionismo doganale, le riforme sociali e anche quelle elettorali. Si potrebbe anche dire che, con lo sviluppo della produzione, con l’affermarsi della cosiddetta seconda rivoluzione industriale e delle concentrazioni monopolistiche, i rapporti di produzione borghesi (della borghesia liberista) entrarono in contrasto con lo sviluppo produttivo.
La contraddizione però, lungi dal dare luogo a una rivoluzione, fu risolta dalla borghesia stessa che puntellò e rinnovò i suoi rapporti di produzione facendo appello allo stato e cooptando al potere le forze della proprietà terriera e della finanza commerciale che un tempo essa aveva spodestato. La contraddizione, insomma, fu risolta con una operazione complessa, ma il cui tratto decisivo fu di natura conservatrice e variamente “prussiana.” L’Italia, come sappiamo, non fece eccezione a questa tendenza. E, anzi, il fatto di dover affrontare i problemi dell’Europa imperialistica senza essere dotata di una salda tradizione liberale la rese particolarmente ricettiva ai nuovi caratteri che ovunque lo stato e l’economia andavano assumendo. Il primo di questi caratteri nuovi ad entrare in Italia fu il protezionismo doganale, richiesto dagli industriali e poi anche da una parte degli agrari. […]
La crescita degli anni 1879-1887 consente di individuare alcuni caratteri di fondo che l’apparato industriale italiano avrebbe mantenuto anche in seguito. Il fatto che negli anni Ottanta il governo mirasse a proteggere soprattutto il settore pesante e navale (siderurgia e armatori) è stato giustificato con l’argomento che, finita dopo il 1873 l’età del capitalismo concorrenziale, il decollo non era più possibile con una dilatazione estensiva degli investimenti, ma solo con una dilatazione intensiva, assegnando la funzione di rottura ad aziende con alta composizione organica di capitale. Ma più convincente di questa tesi sembra quella che critica il governo italiano per aver concentrato la protezione su settori inidonei a promuovere il decollo (Gerschenkron).
Il fatto è che, come già abbiamo detto, la protezione si concentrava non tanto sui settori più promettenti economicamente (meccanici) quanto su quelli più forti politicamente e detentori di posizioni monopolistiche: sui proprietari terrieri, che erano i maggiori garanti dell’ordine sociale; sui produttori di acciaio e di cannoni, e sulla Società di navigazione generale, che fornivano gli strumenti per fronteggiare — magari partecipandovi — la gara imperialistica aperta fra le potenze. In questo coacervo monopolistico decisiva era la funzione dell’acciaio e dei proprietari di terre coltivate a grano (in particolare di quelli assenteisti), cioè dei due settori che, stando a monte del processo produttivo, ricavavano dal monopolio il massimo vantaggio (Lenin). Era il famoso “blocco” protezionistico fra industriali e proprietari terrieri. […]
IL “DECOLLO” INDUSTRIALE
Gli anni che vanno dal 1896 al 1902 costituiscono il nodo centrale della storia d’Italia. Alla base di questo nodo c’era il decollo industriale, il quale, a sua volta, faceva sorgere il seguente problema: quale espressione politica doveva corrispondere al decollo e ai nuovi rapporti sociali che questo creava nel paese: una politica conservatrice reazionaria? ovvero una politica liberale democratica? Si trattava di un dilemma reso bruciante dalla crescita impetuosa del movimento socialista e democratico che sembrava mettere in forse l’egemonia della classe dirigente. Inoltre il dilemma era reso complesso da altri elementi ancora, quali l’influenza della cultura e dell’ideologia, la questione meridionale. […]
Come è noto, gli anni dal 1896 al 1914, e in particolare quelli fino al 1908, costituiscono il periodo nel quale l’economia italiana, approfittando di un lungo ciclo di prosperità mondiale, si forma una base industriale. Grazie all’industrializzazione, il 1901-1913 è l’unica epoca nella storia d’Italia prima del 1950 durante la quale la crescente tendenza alla divaricazione tra il reddito pro capite italiano e quello inglese subì una parziale inversione. […] L’ultimo periodo dell’età crispina, tra le sue varie contraddizioni, ebbe anche quella fra un tipo di politica che voleva essere adatta per affrontare una situazione di emergenza e di crisi e un ciclo economico che invece aveva ormai superato la fase discendente. […]
Il motivo immediato che spinse all’opposizione gli industriali legati prevalentemente al mercato e ostili alla forte spesa pubblica fu, come abbiamo detto, l’intenzione, manifestata da Sonnino, di far loro pagare effettivamente l’imposta di ricchezza mobile perché contribuissero a finanziare la spesa pubblica. Fu allora che gli industriali si unirono ai socialisti e ai democratici nel grido: “Via dall’Africa! basta con le spese militari! ” (D’Angiolini). Il blocco di potere protezionistico si incrinò: mentre l’industria pesante e ampi strati della classe dirigente del Mezzogiorno continentale restavano governativi, l’industria legata al mercato e i latifondisti siciliani passarono all’opposizione, pur non avendo un atteggiamento univoco nei confronti del protezionismo. Infatti per l’industria legata al mercato le esportazioni acquistavano una importanza centrale, la inducevano a considerare con occhio diverso il protezionismo e a combattere quello sul grano, che faceva aumentare il prezzo del pane e, quindi, i salari. […]
Il decollo apportò mutamenti profondi nei nessi fra l’industria pesante e le altre, sia per quanto riguarda l’imperialismo e il commercio con l’estero, sia per quanto riguarda la situazione interna. Dei tre modi classici con cui si manifestava l’imperialismo economico — l’esportazione di capitali, l’esportazione di merci, l’industria di guerra — l’Italia ignorava sostanzialmente il primo. Mentre l’industria pesante puntava sulla politica di potenza e sulla conquista di colonie, l’industria legata al mercato cominciava sempre più a puntare sulle esportazioni.
A causa della scarsa integrazione fra i due settori, particolarmente acuto era il contrasto fra due tipi di politica estera, destinati a dar luogo, nella successiva storia d’Italia, a violente oscillazioni fra l’una e l’altra. Esse non si armonizzarono mai in un senso univoco, come avvenne invece in Inghilterra, la cui grande colonia, l’India, contribuiva a finanziare le esportazioni di capitali dentro e fuori l’impero; o come avvenne in Germania, protesa alla conquista economica di nuovi mercati per i suoi prodotti industriali e, insieme, alla gara navale con l’Inghilterra. L’imperialismo francese, è vero, presentava due settori abbastanza distinti: un settore chiuso nello sfruttamento protezionistico delle colonie, e un altro settore dedicato alla esportazione di capitale da prestito. Ma solo in parte i due settori si intralciavano fra di loro, a differenza di quanto avveniva invece in Italia. La funzione positiva delle spese militari, di creare una domanda addizionale, aveva ancora scarsa importanza in Italia. Grande, centrale importanza cominciavano invece ad avere le esportazioni di merci.
Mentre per l’industria pesante e per i latifondisti il protezionismo era fine a se stesso, per le industrie legate al mercato e per una parte degli imprenditori agricoli (per esempio, i viticultori) cominciavano a diventare uno strumento di contrattazione per aprire nei mercati esteri dei varchi alle proprie esportazioni. Lo sviluppo, come avevano detto Cavour e Cattaneo (ma con l’occhio rivolto prevalentemente all’agricoltura), era legato all’integrazione dell’economia padana con quelle transalpine.
L’aspetto pacifico dell’espansionismo commerciale, la sua tendenza a rivolgersi ai mercati ricchi più che a quelli poveri non gli toglievano il carattere imperialistico. Ciò fu vero anche per l’Italia che pure, per la debolezza economica e la minor concentrazione delle industrie esportatrici, fu meno in grado delle altre potenze di imporre le proprie merci sui mercati esteri con una politica di forza. Le esportazioni italiane acquistarono taluni caratteri dell’imperialismo commerciale man mano che aumentarono per loro d’importanza relativa i mercati poveri dei Balcani e del Levante. Peraltro, fin dall’inizio, un convinto fautore della necessità di esportare come Einaudi pensava non già ai mercati ricchi, ormai dominati dalle economie più avanzate e mature, ma ai mercati poveri e nuovi, forse addirittura sopravvalutando la loro importanza reale.
Si trattava comunque di un imperialismo nettamente contrario alle conquiste coloniali. Gli ambienti economici milanesi erano ben consci dello scarso valore delle colonie come mercati di assorbimento dei prodotti industriali (c’era un’India sola, e già la possedeva l’Inghilterra) ed erano consci altresì che le risorse dei territori conquistati in Africa orientale avrebbero assolto in scarsissima misura alla principale funzione economicamente positiva delle colonie, quella di fornire materie prime. Benché sapessero che l’Italia, per la debolezza del mercato interno e la mancanza di materie prime, era particolarmente sottoposta alle fluttuazioni del commercio mondiale, sapevano anche che essa risentiva in misura particolare i costi di una politica imperialistica intesa a creare, con le colonie e le aree preferenziali, delle dighe contro quelle fluttuazioni. Naturalmente, se il governo era disposto ad accollarsene i costi, non rifiutavano modeste iniziative di imperialismo economico coloniale, come la Società per il Benadir, costituita nel gennaio 1896 dai cotonieri milanesi per la coltivazione del cotone. Ma queste iniziative ebbero sempre per loro un valore marginale.
Forse ancora più importanti furono i mutamenti che il decollo introdusse sul piano interno. L’impetuoso sviluppo industriale che si ebbe nel 1896-1908 fu, soprattutto nella sua prima metà, di tipo estensivo più che intensivo, basato su di un mercato, nazionale ed estero, che “tirava” e che permise l’affermarsi, in misura relativamente cospicua, di nuovi imprenditori. Fu forse il più grosso mutamento e ammodernamento avvenuto nelle strutture economiche dell’Italia settentrionale dall’età dei comuni; superiore a quello che si era precedentemente avuto fra il Settecento e il Risorgimento. Per la prima volta nella storia dell’Italia unita si affacciava sulla scena economica e politica un nuovo ceto, imprenditoriale e moderno, non integrato nei gruppi dominanti, che sembrò mettere in crisi il modo trasformistico di gestire il potere cooptandovi le forze nuove. Questo è, ci sembra, il significato da attribuire, a livello delle strutture, all’opposizione anticrispina di Milano. Questo, soprattutto, è il significato da attribuire alla svolta liberale del 1901.
La medaglia aveva però il suo rovescio. Solo una parte delle industrie, in genere le piccole, decollarono basandosi sull’autofinanziamento. Le più importanti si basarono sull’aiuto e, spesso, sulla iniziativa delle banche. È abbastanza nota, a questo proposito, la funzione centrale svolta dai grandi istituti di credito fondati allora, principalmente la Banca Commerciale e anche il Credito italiano e la Società bancaria italiana: banche di tipo nuovo, non più prevalentemente legate, come le vecchie che la crisi del 1893-1894 aveva travolto, al capitale commerciale e speculativo, ma interessate a promuovere l’industrializzazione.
Il carattere nuovo di queste banche fu reso possibile, in misura grande e forse decisiva, dalla riforma delle banche di emissione, iniziata da Giolitti nel 1893 e attuata da Sonnino, e dal risanamento del pubblico bilancio, attuato dallo stesso Sonnino. La riforma della Banca Romana, che di fatto fu un salvataggio, ebbe i caratteri e le conseguenze tipici di ogni salvataggio (come li avrà, nel 1933, l’IRI): risanò, a spese del contribuente, una situazione in dissesto e liberò capitali, rendendoli disponibili per investimenti più razionali.
La severa gestione della finanza pubblica di Sonnino attrasse in Italia capitali esteri. La creazione della Banca d’Italia, soprattutto grazie al carattere di istituto pubblico che le diede Sonnino, vincendo la resistenza di cospicui interessi privati, mise lo stato in condizione di controllare l’emissione della moneta e, tramite questa, di controllare ed eventualmente sorreggere gli investimenti delle banche di credito. Si trattò in sostanza di una avanzata dello stato nel controllo dell’economia. Questa avanzata, nata sotto il pungolo della crisi economica, creò il legame, tipico del moderno capitalismo finanziario e destinato, da allora in poi, a consolidarsi in occasione di ogni crisi, tra lo stato e le grandi banche di credito.
Il monopolio, lungi dallo scomparire, si era trasformato e allargato. Non era più limitato all’industria pesante e ad alcune delle più grosse aziende tessili ma tendeva ad estendersi, in varia misura, verso la meccanica, l’elettricità, l’elettromeccanica, la chimica. Sebbene (proprio in Italia questo carattere fu particolare evidente) conservasse taluni aspetti propri del periodo precedente, sebbene mirasse più alle posizioni di rendita e alle combinazioni all’efficienza, sebbene fosse più effetto di concentrazione finanziaria che di concentrazione tecnica, tuttavia era destinato, in alcune sue punte più dinamiche (tipico il caso di Agnelli e della Fiat), a svolgere un ruolo centrale ed insostituibile nel promuovere l’ammodernamento tecnologico e lo sviluppo.
L’aspetto socialmente progressivo, costituito dal nuovo ceto imprenditoriale, ebbe il suo contrappeso nel persistente dominio della banca, sia pure trasformata, e nel persistere e anzi nel rafforzarsi del monopolio accanto al settore in crescita estensiva. Occorre precisare che questa distinzione, valida sul piano della struttura e del lungo periodo, non si rifletteva immediatamente nel breve periodo e sul piano della politica. In quegli anni, a quanto pare, non ci fu (o non ci fu in misura macroscopica) la tipica tendenza del monopolio finanziario esercitato dalle banche a discriminare gli investimenti a favore delle aziende industriali più forti per influenze politiche e più legate alle banche stesse, senza tenere nel debito conto il loro grado di dinamicità.
In quegli anni le nuove banche non miravano a frenare ma erano interessate al tipo estensivo di sviluppo in atto, il cui risvolto politico era l’anticrispismo. Ma l’esistenza del monopolio conferiva un carattere strumentale e passeggero agli aspetti democratici dell’anticrispismo. Ciò fa meglio comprendere lo sbocco politico di destra, reazionario, che, nonostante il tipo estensivo dello sviluppo, in un primo tempo si tentò di dare al decollo.
LA CRISI ECONOMICA DEL 1907-1908 E LA SUE CONSEGUENZE
La crisi economica mondiale, iniziata nel novembre del 1907 e durata nell’anno successivo, ebbe in Italia un andamento particolare e più grave. Mentre all’estero fu superata rapidamente, l’economia italiana fu incapace di riassorbirne le conseguenze, che durarono praticamente fino allo scoppio della guerra mondiale, dopo essersi sommate a una successiva crisi nel 1913. Fu non soltanto una crisi economica ma, alla lunga, anche una crisi sociale e politica che contribuì a creare difficoltà crescenti allo stesso sistema giolittiano. Essa pertanto occupa un posto centrale nell’età giolittiana, di cui costituisce una discriminante decisiva.
La debolezza dell’industria italiana e la sua forte dipendenza dall’estero la rendevano particolarmente sensibile all’andamento del ciclo mondiale, con tendenza a prolungarne le fasi di malessere (Cafagna). Ciò risulta più chiaro se si guarda alle cause della crisi del 1907 nel mondo. Le cause furono sostanzialmente due: 1) In conseguenza del boom, i prezzi delle materie prime aumentarono più di quelli dei prodotti finiti, rovesciando la tendenza di fondo in atto dal 1870; 2) L’aumento dei costi provocò uno stato di sovrapproduzione, non solo nei confronti del mercato ma anche nei confronti delle banche, incapaci di far fronte alle richieste crescenti di investimenti e di capitali di esercizio. Il punto 1) colpì in modo particolare l’economia italiana perché priva di materie prime e di un suo retroterra imperiale; il punto 2) la colpì in modo particolare perché legata alle esportazioni di merci e perché povera di capitali.
Di tutti questi aspetti il più grave fu quello del mercato dei capitali che, artificiosamente gonfiato dalla speculazione delle banche nel periodo del boom, fu dovuto contenere, non solo durante la crisi ma anche negli anni seguenti, con una politica delle banche selettiva del credito e sostanzialmente deflazionistica (invano contrastata per un certo periodo dalla Banca d’Italia). Questo fu il principale motivo del malessere persistente in Italia quando all’estero la crisi era ormai superata. Si può avanzare l’ipotesi che l’ampiezza della deflazione fu contenuta e lo sbilancio dei pagamenti con l’estero non provocò il tracollo che aveva provocato nel 1887-1894 grazie alle rimesse degli emigranti: entrate invisibili che assolvevano la stessa funzione compensatrice svolta nelle economie più ricche dai profitti e interessi provenienti dai capitali esportati, e che diedero un contributo decisivo per far uscire l’economia italiana dalla soggezione alla finanza estera. La crisi colpi in misura particolare dapprima l’industria automobilistica, poi quella cotoniera e soprattutto quelle genovesi della siderurgia, dei cantieri, degli armatori navali e dello zucchero. […]
In conseguenza della crisi, l’industria italiana cominciava ad assumere una struttura più matura, denunciata non solo dalla minore importanza del settore tessile ma anche, in armonia con quanto andava accadendo all’estero, dal maggior peso della concentrazione monopolistica. L’economia mondiale che era incappata nella crisi del 1907 si muoveva sostanzialmente ancora nell’orbita dell’economia del 1873-1896, nella quale le difficoltà dell’industria nascevano dal fatto di non essersi sufficientemente integrati gli altri fattori e gli altri settori della produzione, di non poter subordinare al profitto industriale in modo pieno non solo i salari ma anche le banche finanziatrici. Tale subordinazione si avrà solo dopo il 1918 e dopo il 1929. Ma il processo iniziò in seguito alla crisi del 1907, che aveva posto il problema sul tappeto, con particolare riferimento ai rapporti fra l’industria — soprattutto l’industria pesante — e la banca. […]
Il vivo malcontento degli industriali nei confronti delle banche ricordava il loro analogo atteggiamento negli anni Ottanta ed era in parte giustificato dal persistente carattere speculativo della attività del mondo finanziario. Ma solo in parte questa giustificazione era esatta, ché adesso l’atteggiamento delle banche era principalmente dettato dalla preoccupazione di evitare ogni spinta inflazionistica. I fortissimi investimenti fatti dopo il 1905 furono facilitati dalla disponibilità di capitale liberato in seguito alla nazionalizzazione, con riscatto, delle ferrovie. Esauriti questi capitali, gli industriali dovettero arrabattarsi tra l’autofinanziamento, il ricorso diretto al mercato finanziario, le banche, lo stato, il capitale estero. Le capacità di autofinanziamento erano modeste. D’altra parte, nemmeno le risorse del mercato finanziario erano cospicue perchè il risparmio, scottato dalla caduta dei titoli industriali provocata dalla crisi, preferiva adesso i titoli pubblici o il deposito nelle casse postali e di risparmio e nelle banche popolari (Bonelli). Fra il 1909 e il 1913 gli investimenti — pare — rimasero sostanzialmente stazionari.
Constatiamo che in sostanza le conseguenze della crisi aumentarono il peso del capitale pubblico nei confronti di quello privato e confermarono la funzione centrale svolta dallo stato, tramite la Banca d’Italia, per immettere liquidità nel sistema e per salvare la più colpita delle banche miste, la Società bancaria italiana. Le altre due grandi banche, il Credito italiano e, ancora più, la Commerciale, fino allora avevano guardato con diffidenza la Banca d’Italia, considerata strumento di controllo del governo. La crisi del 1907 le indusse ad avvicinarsi all’istituto di stato. […]
All’ombra protettrice dello stato le banche miste, che continuavano ad essere le principali detentrici del credito, accennarono a concentrarsi per rendere più razionale l’erogazione del credito stesso. E poiché ciò che era razionale in quel periodo era il contenimento del credito, il monopolio del capitale finanziario fu ribadito e accentuato sottolineando, fra i suoi aspetti, quelli che agivano da freno sullo sviluppo. Mentre prima della crisi il monopolio del capitale finanziario, pur con le sue attività speculative, era stato un elemento dello sviluppo estensivo, dopo la crisi del 1907 diventò l’elemento centrale e, insieme, il freno dello sviluppo intensivo. Per fare l’esempio più importante, diventò l’elemento centrale dello sviluppo del trust siderurgico e dall’industria zuccheriera ma costituì un freno allo sviluppo di quelle aziende, come l’Ansaldo, escluse dal suo raggio d’azione.
La crisi colpì soprattutto le aziende che dovevano ricorrere al credito bancario, cioè — di norma — le grandi, mentre invece, a quanto pare, le piccole aziende riuscirono meglio a superare la crisi (Bonelli). Sotto questo profilo, a quanto pare, la crisi non approfondì gli squilibri fra le grandi aziende e le piccole. Ma nel complesso la crisi accentuò il dualismo della economia italiana. Accentuò il dualismo fra Nord e Sud perché la maggior partecipazione dello stato alla vita economica significò maggior concentrazione delle risorse al Nord (Bonelli). […]
Poiché il trust siderurgico che faceva capo a Genova era particolarmente legato a Giolitti, questi, per fronteggiare la crisi economica, preconizzò l’intervento dello stato in un modo ancor più netto del suo collaboratore tecnico, Stringher. Mentre Giolitti era disposto a far intervenire direttamente la Banca d’Italia per sostenere il trust, prevalse il parere più cauto di Stringher di imporre questo intervento alla riluttante Banca Commerciale, convenientemente garantita dalla Banca d’Italia (Bonelli). In sostanza, il ruolo della Commerciale divenne quello di intermediaria fra il trust e lo stato. Secondo uno studioso, l’attività principale della Commerciale dopo la crisi del 1907-1908 sarebbero diventate, tramite l’industria pesante da lei finanziata, le forniture di armi allo stato. Nelle intenzioni di Giolitti, a questa azione di sostegno svolta dallo stato avrebbe dovuto corrispondere una azione di controllo e di contenimento.
L’occasione gli fu subito offerta dal fatto che nel 1909 dovevano essere rinnovate le sovvenzioni concesse dallo stato alla marina mercantile e, per questa, alla società armatrice dominante, che era, come sappiamo, la Navigazione generale. La società faceva capo alla Banca Commerciale e agli stessi ambienti economici genovesi per salvare una parte dei quali Giolitti si era mosso con tanta solerzia. Questi ambienti erano costituiti da quattro gruppi: l’Ansaldo, l’Ilva, il Lloyd Italiano di Piaggio e la Navigazione generale. Contro quest’ultima società Giolitti (a differenza di Crispi) nutriva scarsa simpatia perché gestiva una flotta di navi vecchie, continuava a non dare lavoro ai cantieri nazionali e frenava lo sviluppo industriale. L’atteggiamento di Giolitti era largamente condiviso dalla camera dei deputati, che aveva cercato di modificare a vantaggio dello stato, con una legge dell’aprile 1908, i rapporti convenzionali fra questo e la Navigazione generale.
Quando poi la società rifiutò le proposte del governo per il rinnovo delle sovvenzioni, giudicate troppo basse, Giolitti si irrigidì immediatamente perché vide nell’atteggiamento della società un tentativo, fatto da un grande complesso finanziario privato, di imporre la sua volontà su quella dello stato. Giolitti mirò a togliere le sovvenzioni alla Navigazione generale e a darle al Lloyd Italiano, ristrutturato con capitale misto pubblico e privato e sottoposto, almeno nelle intenzioni, a un controllo statale maggiore. Sebbene si trattasse di togliere un monopolio a una società per assegnarlo a un’altra, sembra difficile negare che in Giolitti ci fosse l’intento di affermare la superiorità dello stato su una concentrazione economica privata che aveva voluto deprimerla. […]
IL MONOPOLIO DI STATO DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Il 1910 e i primi mesi del 1911 furono per Giolitti, temporaneamente lontano da responsabilità dirette di governo, un periodo di riflessione. Il fallimento del suo tentativo di deprimere la Navigazione generale era indice di un mutamento nel modo di comportarsi delle concentrazioni economiche, mutamento che, a partire dal 1911, avrebbe trovato nuove conferme. Le grandi industrie, premute dal perdurante malessere dell’economia, accennavano a non essere più disposte ad accettare quella specie di tutela sotto la quale intendeva tenerle Giolitti né ad accettare il riformismo socialista e gli alti salari.
Sebbene Giolitti sottovalutasse l’importanza della cosa, si rendeva conto della opportunità di ostacolare quella tendenza, non tanto per il gusto di una rivincita sullo smacco che la Navigazione generale gli aveva inflitto, quanto per l’obiettiva necessità di turare una falla che minacciava di aprirsi nel suo sistema. Si imponeva, cioè, l’opportunità di riprendere la politica tentata nel 1909 a proposito della Navigazione generale e di darle maggior consistenza, inserendola in un contesto programmatico orientato a sinistra. A questa finalità obbedì il progetto, presentato da Giolitti quando tornò al potere nel marzo del 1911, di sottrarre alla finanza privata e di concentrare in un monopolio di stato le assicurazioni sulla vita.
Il progetto rispondeva non solo alla finalità detta sopra ma anche, e forse anzi soprattutto, a un’altra finalità. Iniziata ormai una politica di riarmo (nel 1911-1914 le spese militari assorbirono oltre il 30% della spesa pubblica), non c’erano margini per attuare riforme sociali. Le sole riforme sociali possibili erano quelle che si autofinanziavano, le riforme che oggi si chiamano di struttura, e tale era l’istituzione del monopolio di stato delle assicurazioni e la creazione di un ente (l’Istituto nazionale assicurazioni, l’INA) che avrebbe dovuto finanziare le pensioni sulla vecchiaia e agire da strumento per fare investimenti pubblici. […] Gli esponenti del capitale finanziario italiano — sia quelli danneggiati che quelli non danneggiati dal progetto — promossero nel parlamento e nel paese una violenta opposizione.
Giolitti riuscì a superare questa opposizione solo rimandando a dopo l’inizio della guerra libica la discussione parlamentare del progetto, che fu infatti approvato sull’onda dell’entusiasmo patriottico e ministeriale provocato dalla guerra stessa. Più che l’opposizione, scontata, delle società assicuratrici, è interessante l’opposizione che al progetto giolittiano mossero, per bocca dell’on. Silvio Crespi, gli industriali. Questi, assillati dalla scarsità di capitali e interessati a trovare mezzi di finanziamento aggiuntivi a quelli delle banche, non vedevano di buon occhio le società assicuratrici, che accusavano di trascurare gli investimenti industriali e di dedicarsi a una attività puramente finanziaria.
Crespi infatti si diceva favorevole alla istituzione di un ente assicurativo di stato che operasse in concorrenza con le società private e calmierasse il mercato assicurativo. In sostanza, egli non era contrario a pubblici interventi, purché questi agissero nell’ambito e in funzione subordinata all’iniziativa privata e, in particolare, al profitto industriale. Ma era nettamente contrario al progetto giolittiano, giudicato un intervento pubblico che mirava invece a sostituirsi, in un determinato settore, alla attività privata, a intaccare il principio del privatismo economico e a porsi — diceva — sulla strada del socialismo. […]
Secondo Bonomi e Nitti, i due più convinti fautori, insieme a Giolitti, del monopolio delle assicurazioni, la funzione dei pubblici interventi era quella, come oggi si direbbe, di incidere sui meccanismi di sviluppo per renderli più razionali. […] Caratteristica del socialriformismo (cioè di quel gruppo di deputati che, capeggiati da Bissolati e Bonomi, nel 1912 si allontaneranno dal Partito socialista e creeranno il partito riformista), e in particolare di Bonomi, fu di voler sostituire l’azione dal basso delle masse con quella dall’alto dello stato, di puntare sull’intervento riformatore dello stato, una volta abbandonato il principio dell’autonomia politica della classe operaia, principio al quale invece Turati restò sempre fedele. […]
Bonomi portò in Italia il revisionismo, con i suoi meriti di voler razionalizzare il capitalismo, e con i suoi limiti di essere il succube di quei monopoli privati che intendeva eliminare o condizionare. Resta il fatto che Bonomi, insieme a Nitti, fu all’origine di una corrente statalista-riformatrice che più tardi avrebbe avuto la sua manifestazione maggiore, sotto veste fascista, con la creazione dell’IRI. Socialriformista era Beneduce che nel 1911-1912 collaborò con Nitti alla istituzione del monopolio delle assicurazioni sulla vita e che fu poi il principale artefice dell’IRI. Nitti, sensibile al valore insostituibile della imprenditorialità e al pericolo dei carrozzoni burocratici, non era fautore così convinto come Bonomi dei pubblici interventi, che fino al 1911 aveva ammesso e sostenuto solo per l’industria elettrica. Prima di diventare ministro nel marzo 1911, era stato contrario alla nazionalizzazione delle assicurazioni, cui lo convinse Giolitti.
Il problema centrale per Nitti non era tanto quello di frenare gli squilibri sociali quanto quello di promuovere e razionalizzare lo sviluppo. Egli si rendeva conto della opportunità di grandi concentrazioni economiche vitali e dinamiche (tipico l’esempio della Fiat di Agnelli); e si rendeva altresì conto dell’opportunità di nazionalizzare quelle concentrazioni (le elettriche) che godevano di posizioni di rendita, pagate dalle altre industrie, e che immobilizzavano dei capitali suscettibili di trovare investimenti più razionali. È plausibile supporre che egli attribuisse soprattutto questa ultima funzione al monopolio di stato delle assicurazioni sulla vita quando si convinse della sua opportunità. Anche Giolitti attribuiva al monopolio delle assicurazioni una funzione analoga. Anche egli era favorevole, non meno di Salandra e di Nitti, alla esistenza di grandi concentrazioni economiche private. Ma avvertiva, in misura assai più acuta di Salandra e anche di Nitti, il preminente bisogno che le concentrazioni non sfuggissero al controllo dello stato e che questo fosse messo in grado di frenare gli squilibri sociali, soprattutto quando, come era stato per le ferrovie, questi squilibri rischiavano di turbare l’ordine pubblico (agitazione dei ferrovieri nel 1902-1903).
Rispetto a quello di Nitti, l’atteggiamento di Giolitti era meno sottile e complesso sotto il profilo economico ma più corposo ed energico sotto il profilo politico. Due fatti indicano in che cosa fossero diverse le concezioni di politica economica dei due uomini: l’ostilità di Nitti nel 1909 al progetto giolittiano di deprimere la potenza della Navigazione generale, perché giudicava il progetto un errore sotto il profilo economico; l’indifferenza di Giolitti verso il progetto nittiano di nazionalizzare l’industria elettrica, progetto che pure rispondeva in pieno alla razionalità economica, probabilmente perché avrebbe provocato forti ostilità, ritenute da Giolitti un rischio politico eccessivo. In sostanza Giolitti assegnò al monopolio delle assicurazioni alcune finalità specifiche nelle quali la funzione di frenare gli squilibri si univa a quella di promuovere lo sviluppo: mettere a disposizione dello stato i mezzi per finanziare le pensioni di invalidità e vecchiaia, rafforzare lo stato sul piano economico per metterlo in grado sia di meglio fronteggiare le grandi concentrazioni private sia di promuovere lo sviluppo durante le crisi (come era avvenuto nel 1908).
È plausibile supporre che Giolitti, constatata l’insormontabile opposizione che il tentativo da lui fatto nel 1909 contro la Navigazione generale aveva provocato, scegliesse il campo delle assicurazioni che, per essere un campo puramente finanziario senza connessioni dirette nel campo industriale, avrebbe dovuto essere capace di dividere il blocco degli interessi bancari-industriali e avrebbe dovuto suscitare una opposizione meno violenta. Così infatti avvenne: ma solo in parte. Infatti la difesa del principio del privatismo fu più forte del contrasto tra interessi industriali e interessi finanziari. L’unità del capitale finanziario fu più forte dei suoi dissensi interni. Gli avversari del monopolio di stato delle assicurazioni dovettero, sì, accettarlo, ma riuscirono ad imporre a Giolitti di rimandarne di 10 anni l’istituzione.
Dieci anni dopo c’era al potere Mussolini, del quale, come è noto, uno dei primi atti di governo, in armonia a quanto richiesto dagli ambienti economici milanesi che lo sostenevano, fu quello di rinunciare al monopolio di stato delle assicurazioni sulla vita e di limitarsi a mettere in attività un istituto pubblico (l’INA), destinato ad operare in concorrenza con le società private e ad esercitare una funzione calmieratrice sul mercato delle assicurazioni. Era esattamente quello che nel 1911 gli industriali avevano chiesto per bocca di Silvio Crespi, che Giolitti non aveva voluto concedere e che Mussolini concesse.
Se consideriamo nel loro insieme gli interventi fatti o tentati da Giolitti per eliminare o controllare il potere di determinati settori economici dominanti, vediamo che furono tutti diretti contro le concentrazioni e contro le attività speculative che erano nate e che erano state tipiche del periodo anteriore al decollo industriale: contro le compagnie ferroviarie private, contro la Società di navigazione generale, contro i detentori della rendita delle aree fabbricabili, contro le società di assicurazione. Gli interventi pubblici giolittiani si inserivano in un disegno generale volto a deprimere i settori vecchi e arretrati del capitale finanziario per esaltare quelli nuovi. Ma di tutti gli interventi, il solo che riuscì pienamente fu la nazionalizzazione delle ferrovie, che colpiva un settore al quale il grande capitale era ormai interessato solo marginalmente. Gli altri interventi, quelli più suscettibili di creare dei correttivi alla spontaneità del privatismo, fallirono, sia pure in misura e in tempi diversi.
Poiché, inoltre, Giolitti lasciò indisturbata la rendita fondiaria agraria, si può ribadire che, sebbene le sue simpatie andassero alle forze moderne del capitalismo, la sua politica le fece convivere con quelle arretrate e consolidò, sia pure su basi mutate, l’ormai tradizionale blocco economico di potere. Con tutto ciò, nonostante il loro sostanziale fallimento, quegli interventi testimoniano della alta concezione giolittiana dello stato e dei suoi compiti in una società moderna, concezione che gli esponenti del privatismo ben conoscevano e temevano. Quegli interventi testimoniavano la coerente volontà di Giolitti di non escludere l’ipotesi di trovarsi in conflitto con i monopoli privati e di cercare strumenti per limitarne il potere.
È lecito concludere che quegli interventi, se riuscirono solo in piccola parte a riformare il sistema e renderlo più razionale e meno squilibrato, furono aspetti essenziali della corretta gestione giolittiana del sistema così come era. Anche sotto questo profilo lo stato di Giolitti costituisce un momento particolarmente felice della sua storia. Dopo Giolitti lo stato non ha mai più fronteggiato i monopoli privati da posizioni di forza.
Fonte: G. Carocci, Storia d’Italia dal 1861 a oggi, Feltrinelli, Milano, 1975
Introduzione e redazione a cura di Luscino

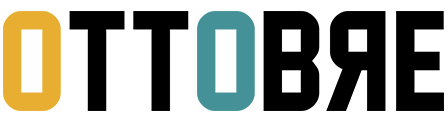





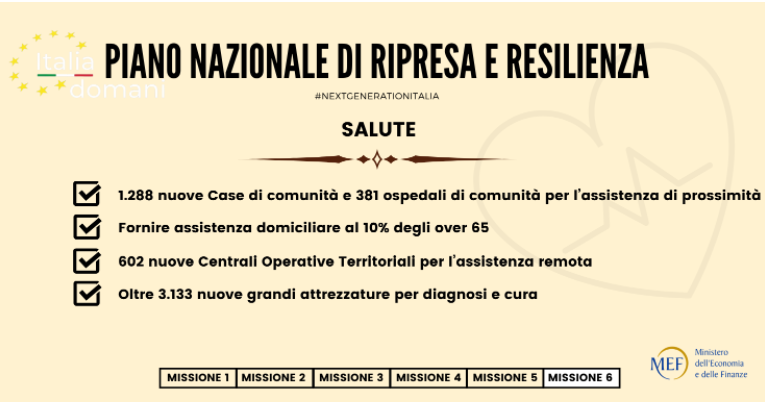

[…] del capitalismo in Italia. Dopo i primi due capitoli sulle origini del capitalismo e sul suo sviluppo nel periodo dell’Italia liberale, ci affacciamo a quel periodo di massimo consolidamento del capitalismo monopolistico italiano che […]
[…] il primo secolo di storia del nostro paese sin dalla sua fondazione: dalle origini, all’Italia liberale, al regime fascista. In questo capitolo Carocci analizza con lucidità gli accadimenti che dopo il […]