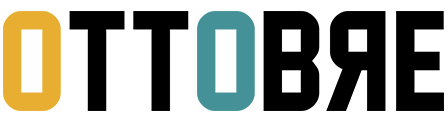In tempi di rinnovata sinofobia dovuta alla retorica razzista messa in campo dai circoli dirigenti USA (che ha trovato terreno fertile anche in Italia con indegne sortite del mondo politico e della stampa contro “i cinesi untori”) per cercare di trovare capri espiatori agli effetti della pandemia da Covid 19, presentiamo la traduzione di un articolo di Mark Tseng-Putterman. L’autore indaga qui in prospettiva storica il legame tra imperialismo, razzismo e violenza antiasiatici nell’ottica della lotta globale contro le pretese egemoniche degli USA, ancor più infide quando rivestite, come spesso è il caso, da una ideologia sedicente “liberale e antirazzista”.
di Mark Tseng-Putterman
Questa è New York City, non il Vietnam!
Sono queste le parole con le quali Le Mi Hanh, studentessa delle superiori del Queens, New York, si sarebbe rivolta all’uomo che l’aveva seguita nel suo condominio, legandola in un appartamento sfitto e accusandola di essere una Vietcong. L’uomo in questione era Louis Kahan, trentenne, ex-marine e veterano del Vietnam il quale, in seguito, dichiarò che il caldo di New York e le macerie edili avevano innescato ricordi del suo periodo in prima linea.
Il brutale stupro e omicidio di Le, per mano di Kahan nel 1977, feceva collassare la netta segregazione spaziale tra la violenza “all’estero” e quella “interna”. Le era stata prescelta dagli Stati Uniti per una vita migliore, essendo stata espatriata durante la caduta di Saigon e il ritiro delle truppe statunitensi dal Vietnam nel 1975. Nativa di Saigon, figlia di un professore vietnamita e studentessa modello alla New York’s Jamaica High School, l’apparente storia di successo del suo reinsediamento aveva servito da rivincita simbolica per le guerre USA nel Sud Est asiatico nonché testimonianza delle libertà presenti nella società americana.
Ma agli occhi del suo assassino, non era altro che l’ennesima “gialla” da sottoporre alla stessa politica di violenza indiscriminata che Kahan era stato indottrinato a esercitare all’estero. Di fronte al crudo odio razziale di un veterano disturbato, il sofisticato edificio innalzato dallo stato USA al fine di delineare l’immagine, entro i confini statunitensi, della “minoranza modello” di rifugiati e, all’estero, di “nemici combattenti”, finiva per crollare.
Nel corso di un processo senza giuria, Kahan veniva ritenuto “non responsabile, causa infermità mentale” del tragico omicidio di Le. Ascrivendo quest’ultimo ai deliri paranoidi di un veterano traumatizzato, il sistema giudiziario penale e i media meinstream deferivano una più ampia resa dei conti con la politica di deumanizzazione istituzionalizzata governante la violenza militare statunitense nel Sud Est asiatico. Le demarcazioni ufficiale tra guerra e rifugio, nemico e alleato e, ancora, tra “giallo” e rifugiato, esigevano che Kahan venisse dipinto come l’eccezione e non la regola. Il vecchio assioma di Kipling ne risultava così aggiornato per un’epoca di guerra permanente e multiculturalismo: il Vietnam era il Vietnam, New York era New York, e mai si sarebbero incontrati.
Questa distinzione ufficiale tra violenza militare istituzionalizzata in Asia e “odio” razziale individualizzato domestico condiziona tutt’ora i tentativi di analizzare e affrontare le radici della violenza anti-asiatica. Oltre un anno di attacchi e persecuzioni razziste alimentati da razzismo pandemico, in aggiunta all’omicidio di sei donne asiatiche ad Atlanta e quattro membri della comunità Sikh a Indianapolis, hanno conferito una rinnovata visibilità politica alla persistenza del razzismo anti-asiatico. Tuttavia, formulazioni popolari come l’hashtag “#StopAsianHate” occultano le radici istituzionali e internazionali della violenza anti-asiatica, e ciò a favore di una visione liberale dell’applicazione interna dei diritti civili e della “sensibilizzazione” per combattere i pregiudizi individuali.
La disinternazionalizzazione dell’”odio” anti-asiatico attiva una strana contraddizione: la relativa visibilità della violenza che ne è espressione negli USA è stata accompagnata dalla silenziosa espansione della presenza militare statunitense in Asia, eredità bipartisan del cosiddetto “pivot to Asia” di Obama e del virulento attacco alla Cina dell’epoca Trump. Insistere sul collegamento tra le due cose significa sfidare l’autodesignazione da parte dello stato quale volto della tutela antirazzista anziché della forma istituzionalizzata del razzismo. Tali connessioni sono oscurate dalla lente dominante dell’antirazzismo liberale, sempre più utilizzata al fine di naturalizzare il ruolo degli apparati repressivi dello stato – dalla presenza della polizia locale alla mobilitazione militare a livello internazionale – per “proteggere” le popolazioni asiatiche e americane asiatiche.
In un periodo in cui gli Stati Uniti, simultaneamente, prendono di mira la regione “Indo-Pacifica” come principale teatro militare e si candidano alla difesa delle comunità americane asiatiche, la critica dell’impero emerge come il tessuto connettivo necessario a rigettare una simile narrazione carceraria di protezione statuale. Gli appelli abolizionisti e antimperialisti all’autodeterminazione e a una visione di sicurezza e solidarietà gestite dalle comunità richiedono un’espansione dei confini concettuali della violenza anti-asiatica, in vista di una diagnosi sistemica e globale di militarismo, imperialismo e razzismo.
Una cronologia alternativa della violenza anti-asiatica
Nel contesto di una cultura nazionale intrisa di amnesia ed eccezionalismo riguardo all’esperienza americana asiatica, la cosiddetta “impennata” della violenza anti-asiatica ha suscitato rinnovati tentativi di storicizzare le origini di questo razzismo. La retorica sul “virus cinese” sfoderata da Donald Trump ha ben presto suggerito comparazioni storiche con l’associazione tra migranti cinesi e malattie infettive tipica del XIX secolo. Immagini scioccanti di violenza di strada contro ignare vittime asiatiche hanno evocato la vicenda di Vincent Chin, il cittadino sinoamericano pestato a morte a Detroit nel 1982 da due uomini bianchi, i quali avevano individuato nei tratti estasiatici di Chin un simulacro dell’industria automobilistica giapponese che ritenevano responsabile del declino nelle loro condizioni di vita. Gli storici hanno inoltre accennato a precedenti azioni di vigilanti e alla violenza di stato contro gli americani asiatici, citando massacri anti-cinesi risalenti al XIX secolo come quello di Rock Springs in Colorado nel 1885 e l’incarcerazione di giapponesi e nipoamericani durante la Seconda guerra mondiale.
Ordinarie cronologie della violenza anti-asiatica che rivelano tanto quanto occultano. Generalmente assenti in questi resoconti storici sono invece episodi come Il Massacro del Cratere Moro nel 1906, nel corso del quale le forze statunitensi uccisero più di 800 combattenti indipendentisti filippini per poi mettersi in posa coi loro cadaveri nelle fosse comuni; o ancora, il Massacro di My Lai nel 1968, quando 504 civili vietnamiti vennero assassinati dalle truppe USA. Sebbene l’omicidio di otto persone, tra cui sei donne asiatiche, avvenuto ad Atlanta il 16 marzo 2021 abbia condotto a un importante disamina a livello nazionale circa le specifiche violenze subite dalle donne asiatiche e dalle sex worker, la narrazione dei media mainstream ha in larga misura eluso rilevanti interventi di attivisti di base e studiosi, i quali hanno inserito la tragedia in un contesto globale in cui le donne asiatiche sono spesso bersaglio di violenza razziale e di genere da parte del personale militare statunitense nelle “camptown” di Okinawa, in Corea, nelle Filippine e altrove.
Nei primi mesi della pandemia, i progressisti americani asiatici hanno criticato aspramente il cinico patriottismo emblematizzato dall’appello lanciato da Andrew Yang [candidato a sindaco di New York di origini taiwanesi, n.d.t.] a combattere la violenza anti-asiatica “vestendo a stelle e strisce”. Ma ciò nonostante, molti sono rimasti aggrappati a una visione concettuale dei confini di tale violenza in cui è preminente la nazionalità USA delle vittime. Al contrario, i movimenti contro l’imperialismo e il militarismo in Asia hanno avuto a lungo come guida una critica della violenza razziale, specialmente contro le donne in generale e le sex worker in particolare. Gli assassinii di Yun Geum-i in Corea nel 1992, Jennifer Laude nelle Filippine nel 2014 e Rina Shimabukuro a Okinawa nel 2016 hanno contribuito a dare il via a rinnovati movimenti nazionali per la demilitarizzazione e l’autodeterminazione; tuttavia, queste tragedie non hanno suscitato corrispettive discussioni negli Stati Uniti riguardo alla violenza che tale paese infligge in Asia. Silenziamenti non casuali, bensì strategici, che agevolano la scissione dei movimenti antirazzisti interni dalle lotte internazionaliste contro l’impero.
Eppure, al culmine della Guerra del Vietnam, erano proprio tali collegamenti tra il razzismo anti-asiatico “in patria” e l’imperialismo statunitense all’estero ciò su cui insistevano gli attivisti americani asiatici contro la guerra. Come scriveva Mike Murase sulle pagine di Gidra, rivista radicale americana asiatica pubblicata a los Angeles, il razzismo fronteggiato dagli americani asiatici era intrinsecamente connesso al conflitto nel Vietnam. Esprimendosi sulla necessità di un contingente asiatico alle manifestazioni nazionali contro la guerra del maggio 1972, Murase così argomentava: “la sistematica deumanizzazione dei `gialli´ nell’esercito colpisce anche gli asiatici negli Stati Uniti, poiché è proprio qui che rientrano gli assassini addestrati di asiatici”.
Agli occhi degli attivisti contro la guerra americani asiatici, l’ideologia razziale trascendeva le frontiere nazionali, unendo i popoli asiatici in una lotta comune contro la miriade di violenze della supremazia bianca globale. L’organizzatore Mike Eng coglieva questa interrelazione paragonando le pattuglie del Dipartimento di polizia di Los Angeles a Chinatown con una forza di occupazione all’estero. Riferendo sempre su Gidra a proposito delle violenze e degli abusi su base razziale esercitati dalla polizia nei confronti dei giovani di Chinatown nell’estate del 1971, Eng individuava una “mentalità da My Lai” che “aveva fatto ritorno in patria insieme alle truppe”.
In simili momenti d’incontro razziale, il corpo asiatico è servito da avatar per la traslazione delle ideologie imperiali che ritraevano gli asiatici quali nemici ufficiali, marchiati ai fini della distruzione. Un’illustrazione di Alan Takemoto, apparsa sulla copertina di Gidra nel maggio 1972, cristallizzava la dialettica tra razza e impero in termini provocatori: un soldato americano asiatico, trovandosi di fronte quella che pare essere una vietcong, chiede al suo comandante: “che cosa dovrei fare ora, Joe?”, al che l’ufficiale gli risponde: “ammazza quella gialla, muso giallo!”.
Affrontare un impero “antirazzista”
La vistosa assenza dell’imperialismo USA nelle discussioni intorno al razzismo anti-asiatico è apparsa in bella mostra quando l’attuale Segretario di stato Anthony Blinken ha trovato il tempo, nel corso del suo viaggio diplomatico in Asia, per condannare il massacro di Atlanta. In una conferenza stampa a Seoul, Blinken ha dichiarato di essere “inorridito da questa violenza che non ha posto in America”. Analogamente, il Segretario alla difesa Lloyd Austin ha stigmatizzato quello che ha definito “un orribile crimine”.
Un tale ipocrisia imperialista è degna di nota. Il tour di Blinken e Lloyd aveva l’obiettivo esplicito di sostenere un ulteriore incremento dell’apparato militare statunitense nella regione. Il Pentagono sotto gestione Lloyd sta lanciando un’iniziativa di “deterrenza” nel Pacifico da 27 miliardi di dollari, al fine di espandere le basi militari USA, la capacità missilistica e le esercitazioni belliche in un’area che gli Stati Uniti definiscono ormai come il loro principale teatro di guerra. Mentre le guerre guerreggiate del XX secolo in Corea e Vietnam sono recedute nella memoria generazionale, Blinken e Lloyd ereditano – e cercano di ampliare – le infrastrutture della militarizzazione permanente di cui qui conflitti sono stati l’epitome.
Questo apparato militare da guerra fredda si è dilatato divenendo un “impero delle basi” con un quarto di milione di personale militare USA impiegato in oltre ottocento installazioni militari ufficiali all’estero. Una rete imperialista sempre più posizionata al fine di accerchiare la Cina: anche quando infuriavano le guerre in Afghanistan e Iraq, i funzionari dell’amministrazione Obama definivano il XXI secolo come il “secolo del Pacifico” richiedente un cosiddetto “pivot to Asia” in modo da fronteggiare una Cina “in ascesa”. Una tendenza inasprita tanto dall’amministrazione Trump, con l’individuazione della Cina quale “competitore strategico” e “priorità numero uno del Pentagono”, che da quella Biden, con la sua bellicosa promessa elettorale di durezza nei confronti di “canaglie” come Xi Jinping e Kim Jong-un.
Alcuni osservatori hanno segnalato come il linguaggio dell’assalitore di Atlanta, il quale descrive le donne come “tentatrici”, rientra a pieno nel discorso imperialista in cui i corpi delle donne asiatiche sono ritratti come parte del bottino di guerra USA. In tale contesto, l’ipocrita condanna della violenza anti-asiatica espressa da Blinken e Lloyd svetta in netto contrasto col loro ruolo di architetti di un apparato militare globale, lo stesso apparato che agevola la violenza endemica delle basi militari statunitensi in Asia. In Corea, nelle Filippine, a Okinawa e altrove, questa violenza – non di rado sessuale – è messa a tacere tramite accordi congiunti circa lo status delle forze armate, intese che proteggono i militari USA da processi nei tribunali locali per le violenze commesse, ostacolando la giustizia per le vittime dell’occupazione statunitense.
Le parole di Blinken ereditano un abusato paradigma di guerra liberale che rappresenta l’esercito USA non come dispensatore di violenza, ma come virtuoso guardiano contro quest’ultima. In tal senso, le condanne della violenza da parte di prestanome della brutalità imperiale non sono semplicemente ipocrite, bensì paradigmatiche. La presunzione dell’imperialismo statunitense consiste nell’incorniciare le miriadi d’interventi e occupazioni con cui si manifesta non come distruttive – della sovranità, degli ecosistemi e delle condizioni di vita locali – ma come produttive – di libertà, individualità liberali e capitalismo del libero mercato. Sorretto da una narrazione liberale incentrata sulla difesa, il sanguinoso ordine postbellico della supremazia USA è invece restituito come una benevola “Pax americana”. La storica Monica Kim così descrive il cambio di paradigma segnato dalla Guerra di Corea: “la guerra dovrebbe essere condotta in nome dell’`umanità´… condotta quale disconoscimento della guerra stessa”.
Queste concezioni militarizzate della libertà continuano a strutturare la geopolitica statunitense in Asia e non solo. Le amministrazioni Trump e Biden hanno entrambe avanzato il concetto di una “regione indo-pacifica libera e aperta” come caposaldo strategico della politica regionale USA. Ma un documento quadro strategico declassificato del 2018 delinea cosa intendono i decisori politici col termine “libertà”. Le massime priorità indicate per la strategia statunitense indo-pacifica sono “preservare l’accesso economico, diplomatico e militare USA”, “mantenere la primazia USA” e “avanzare la leadership economica globale USA”. Non vi può essere alcun dubbio, il discorso dell’interventismo liberale – legittimato come difesa necessaria contro spauracchi regionali come la Cina e la Corea del Nord – fornisce tutt’ora la copertura a un progetto di egemonia regionale statunitense.
La promessa fatta da Blinken di “stare al fianco della comunità coreana”, sull’onda della tragedia di Atlanta, si allinea dunque con l’impegno USA a “difendere” la Corea del Sud da un vicino del nord dato per scontato come bellicoso e dal grilletto facile – e questo in contraddizione coi movimenti transfrontalieri miranti alla pace e alla riunificazione. Entrambe le narrazioni pongono gli Stati Uniti non come il principale dispensatore di violenza razziale, bensì come benevolo guardiano incaricato di disciplinare “l’odio”, inteso o nella forma di pregiudizio individualizzato o in quella di “stati canaglia” che sfidano l’ordine egemonico USA.
Lo stato razziale antirazzista
Non sorprende che la condanna della violenza anti-asiatica espressa da Blinken e Lloyd abbia trovato un eco nei vertici dell’amministrazione statunitense: il presidente Biden ha descritto in modo antistorico i recenti attacchi contro americani asiatici come “antiamericani”. Persino Donald Trump si visto costretto nel marzo dello scorso anno a twittare in loro difesa, invocando da parte degli USA la “piena protezione” della comunità nel bel mezzo della violenza alimentata dalla politicizzazione della pandemia da lui stesso intrapresa ai fini di un’agenda geopolitica aggressiva nei confronti della Cina.
Per quanto sia ragionevole far pressione sui leader politici affinché condannino tale violenza, la funzione di questo antirazzismo ufficiale è ben più circospetta. Le vuote sconfessioni statali dell’”odio” anti-asiatico servono a dissociare gli atti razzisti individuali dai loro corollari sistemici: la prosecuzione della deportazione dei rifugiati del Sud Est Asiatico da parte dell’amministrazione Biden, la criminalizzazione del sex-work e l’espansione della presenza militare statunitense in tutta l’Asia.
In tal senso, l’antirazzismo liberale può essere inteso come il complemento interno alla guerra liberale, in cui la struttura del razzismo stesso è sempre più inscritta nel suo disconoscimento. Entrambi i discorsi ripropongono la responsabilità dello stato nel vigilare su quella violenza che ha creato. Qui, l’autodesignazione degli Stati Uniti quale “poliziotto globale” è illuminante: la posa “difensiva” dell’occupazione militare USA all’estero riflette i rinnovati appelli a “proteggere” le comunità americane asiatiche dalla violenza razziale.
Appelli che hanno subito trovato slancio fornendo una facciata progressista all’espansione dell’apparato poliziesco. Ad esempio, il Dipartimento di polizia di New York ha costituito, nell’agosto 2020, un’unità contro i crimini d’odio anti-asiatici, nel genereale sconcerto delle organizzazioni della comunità americana asiatica locale, le quali ritengono il dipartimento stesso una fonte di violenza sistemica che prende di mira residenti, immigrati senza documenti, sex worker e anziani americani asiatici. Sulla stessa scia, il presidente Biden ha annunciato a marzo che l’FBI terrà “iniziative di formazione sui diritti civili a livello nazionale”, come parte di un’azione presidenziale rivolta contro la violenza anti-asiatica. Intenti carcerari che riguardano meno la sicurezza delle comunità americane asiatiche che la reificazione del ruolo punitivo dello stato inteso come arbitro ufficiale dell’antirazzismo.
L’assassinio da parte della polizia di Dante Wright a Brooklyn Center e Adam Toledo a Chicago intensificano ulteriormente la promozione ideologica di un “antirazzismo” poliziesco per combattere la violenza anti-asiatica. A lungo individuati come una “borghesia razziale”, strumentalizzati al fine di disciplinare le comunità nere, latine e indigene, ora col dispiegamento di unità contro i crimini d’odio anti-asiatici, nel mezzo delle richieste a livello nazionale di abolizione della polizia, si materializza lo spettro della manipolazione degli americani asiatici allo scopo di rafforzare la legittimità morale delle forze dell’ordine come istituzione. La bontà morale di quest’ultima in quanto incaricata di “proteggere” le comunità asiatiche vulnerabili, in uno schema all’insegna del divide et impera, verrà posta come negazione simbolica della violenza inflitta da quella stessa polizia alle comunità razzializzate della classe operaia.
Ancora una volta, la connessione della critica abolizionista e antimperialista ci aiuta a individuare i raggiri della protezione statale e della riforma. Mentre le immagini delle forze di polizia militarizzate nelle città statunitensi suscitano spesso critiche sulla “guerra che torna in patria”, dovremmo invece intendere polizia ed esercito quali strumenti congiunti di un apparato repressivo, progettato al fine di rafforzare le condizioni necessarie a sostenere il capitalismo razziale a livello interno e globale. Questi circuiti sovrapposti e reciprocamente costitutivi di orientalismo e sentimento anti-nero formano un regime capitalistico razziale, il cui smantellamento richiede linguaggio e lenti che vadano oltre qualsiasi visione vincolata a un punto di vista individualizzato e identitario di contrasto all’odio o al pregiudizio.
Al di là dell’appartenenza
Con un intervento melodrammatico, lo scorso mese, il politicante dell’Ohio Lee Wong ha affrontato il tema del razzismo contro gli americani asiatici nel corso di una riunione della comunità locale. “La gente mette in dubbio il mio patriottismo, dice che non sembro abbastanza americano”, ha lamentato Wong. Quindi, mettendo in mostra una lunga cicatrice sul petto risalente al suo servizio nell’esercito degli Stati Uniti, Wong ha gridato: “non è forse questo abbastanza patriottico?”.
Il video dell’intervento è divenuto virale, totalizzando milioni di visualizzazioni su YouTube e Twitter da parte di utenti che hanno plaudito al patriottismo e allo spirito di servizio di Wong. Tuttavia, la logica secondo la quale l’americanità è un prerequisito del riparo dalla violenza razziale – sorvolando sul fatto che tale americanità viene dimostrata al meglio tramite la guerra – è inquietante.
Simili richiami all’appartenenza degli americani asiatici risultano complicati alla luce della storia di strumentalizzazioni del multiculturalismo come tattica della guerra liberale. Il genere del “multiculturalismo militare” ha posto a lungo il militarismo USA quale un crogiolo di progresso razziale anziché istigatore di guerra razzista. La desegregazioni delle unità dell’esercito durante la Guerra di Corea, ad esempio, ha ammantato nei termini dell’unità nazionale bianchi-neri quell’intervento genocida. Analogamente, le decorazioni al servizio militare di tutte le unità nippo-statunitensi attive nella Seconda guerra mondiale ha voluto segnare una parabola redentiva rispetto all’incarcerazione di 120.000 giapponesi e nippoamericani.
Questo pernicioso multiculturalismo consente una selettiva incorporazione entro i bracci dello stato razziale al fine di fornire legittimazione al persistere del sistema razzista in un’epoca di antirazzismo ufficiale. All’interno di una tale paradigma, le strutture dello stato razziale possono essere consolidate non dall’esclusione fobica bensì da un’inclusione solidale. Se le insensibili dichiarazioni del comandante della Guerra del Vietnam William Westmoreland, secondo il quale “la vita in Oriente ha poco valore”, rappresentano un registro del razzismo imperiale, la recente ode al sundubu-jjigae [piatto della cucina coreana, n.d.t.] da parte di Antony Blinken rappresenta un discorso imperialista ora meno definito dall’esplicita deumanizzazione che da un’accettazione multiculturale di una “differenza” depoliticizzata. L’apparato di un impero militare globale e la violenza che perpetra non sono cambiati – sono invece mutate le narrazioni che lo agevolano.
Il tranello dell’antirazzismo liberale assume un’inedita urgenza in un momento in cui i discorsi atti a giustificare l’egemonia statunitense fronteggiano una crisi di legittimità su tutti i versanti. Dalla catastrofica risposta alla pandemia all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, passando per le correnti insurrezioni abolizioniste nere – il senso comune circa una guida morale USA del mondo viene sempre più messo in questione. In tale contesto, l’antirazzismo ufficiale, inteso come discorso legittimante del dominio razziale, minaccia di sussumere le contraddizioni di questa crisi alle nozioni progressiste di una riforma lenta e benevola. Simboli depoliticizzati del liberalismo razziale compiono un simile lavoro di legittimazione: striscioni con scritto Black Lives Matter adornano l’ambasciata statunitense a Seoul e la frase viene dipinta sulle strade di Washington D.C. Un Segretario alla difesa nero è lodato come icona di progresso – e poco importano i suoi stretti legami con l’industria degli armamenti. Atti di particolare violenza vengono denunciati come “antiamericani” – senza porre in questione le strutture del razzismo che li rendono possibili.
La rinnovata visibilità della violenza anti-asiatica costituisce un’esortazione critica a espandere il nostro concetto di violenza razziale oltre i parametri di appartenenza, nazionalità, classe o parentela. Al contrario, i discorsi incentrati sulla “deterrenza” militarizzata in Asia e sulla “protezione” poliziesca a livello locale mirano ad addomesticare una critica radicale della violenza sistemica, a favore di una narrazione legittimante che pone l’autorità statale militarizzata come arbitro della violenza razziale, quando invece ne rappresenta la sua principale e costitutiva forma. In un periodo in cui l’area “Indo-Pacifica” è presa di mira quale principale teatro del potere militare USA, e l’appello a “fermare l’odio anti-asiatico” viene sfoderato come un mandato per l’intervento dell’autorità statale nelle comunità razzializzate, riportare l’imperialismo al centro dell’attenzione coincide invece con l’esporre gli inestricabili circuiti globali di razzismo, imperialismo e capitalismo alla radice della violenza razziale.
*Mark Tseng-Putterman è uno scrittore e dottorando la cui ricerca accademica si concentra sulla geopolitica statunitense durante la guerra fredda, le infrastrutture dei media e i movimenti sociali americani asiatici. I suoi scritti su razza, impero e comunità americana asiatica sono comparsi su The Atlantic, Boston Review e Truthout.
Articolo originale https://roarmag.org/essays/anti-asian-racism-american-imperialism/