Con questo scritto di G. Carocci concludiamo la panoramica sulla storia del capitalismo italiano, che ha abbracciato il primo secolo di storia del nostro paese sin dalla sua fondazione: dalle origini, all’Italia liberale, al regime fascista. In questo capitolo Carocci analizza con lucidità gli accadimenti che dopo il secondo conflitto mondiale costituirono quel che fu l’ennesimo tornante dello sviluppo del capitalismo in Italia. In questo caso la ricostruzione e tutto ciò che essa comportò in termini economici e politici: dall’acquiescenza dei comunisti che in nome della strategia della “democrazia progressiva” si lasciarono fagocitare dal parlamentarismo borghese, lasciando ogni iniziativa al nemico di classe; alla Democrazia cristiana che gettava le basi per la salda ripresa del potere da parte della borghesia e dell’estensione della sua egemonia fra le masse, potere coercitivo ed egemonia che erano stati scossi dalla guerra e dalla Resistenza contro il regime fascista. Dalla frustrazione per le mancate riforme economiche richieste a gran voce dalle masse, alla recrudescenza del potere padronale che, ancora, attraverso il “nuovo” Stato riaffermava il giogo borghese sulla classe operaia.
La borghesia, come mette ben in luce il presente scritto, poteva operare così il suo gattopardesco cambio di regime mostrandosi, laddove le condizioni contingenti lo richiedevano, ora erede della peggiore Italia liberale, ora di quella fascista, il tutto condizionato in larga parte dalla sudditanza nei confronti dell’imperialismo statunitense che da presso ha “vegliato” sulla costruzione della Repubblica nata dalla negazione della Resistenza. La narrazione si arresta ai primi anni 60, prima del tentativo di svolta reazionaria di Tambroni e poi del successivo tentativo del cosiddetto “centro-sinistra”; un tempo tuttavia sufficiente per scorgere il tracciato sul quale si era incanalata la politica e l’economia dell’Italia.
De Gasperi fu il leader democristiano che, con abilità ed energia, seppe resistere alle spinte più rozzamente clericali e a quelle reazionarie del Vaticano, e, insieme, seppe contenere la spinta rinnovatrice della Resistenza, fare del suo partito il centro di raccolta dei conservatori e delle forze tradizionalmente dominanti, e riconsegnare a queste ultime, pur con modi nuovi, il potere politico ed economico. Principale punto di forza di De Gasperi fu la fiducia che riposero in lui gli americani. Non è un caso che egli venisse nominato Ministro degli Esteri in quel gabinetto Bonomi del dicembre 1944 che, dopo i sintomi premonitori dei mesi precedenti, segnò l’inizio della involuzione politica della Resistenza, e che conservasse ininterrottamente la carica fino al febbraio del 1947, cioè per tutto il periodo durante il quale si svolsero i negoziati del trattato di pace fra l’Italia e le potenze vincitrici. Ed è indicativa la diversa e maggiore considerazione che, nella seconda metà del 1945, il rappresentante americano a Roma dimostrava verso De Gasperi rispetto a quella che dimostrava verso il presidente del consiglio, Parri.
De Gasperi affermò costantemente che la politica interna doveva essere subordinata alle ragioni, decisive, della politica estera, in pratica, che i suoi sforzi intesi a indebolire i comunisti erano diretti a ottenere condizioni migliori nel trattato di pace e in materia di rifornimenti e aiuti economici. Nel negoziato per il trattato di pace l’avversario principale dell’Italia era la Jugoslavia comunista, appoggiata dall’URSS, con le sue pretese territoriali sulla Venezia Giulia. Gli Stati Uniti invece, che erano ormai la potenza leader dell’Occidente capitalistico, appoggiavano di preferenza l’Italia, cui assegnavano una funzione di rilievo nel sistema strategico occidentale antirusso. Inoltre gli Stati Uniti erano la sola potenza in grado di fornire grossi aiuti in materia economica e di agevolare la ripresa dell’industria italiana.
In realtà, nonostante l’indubbia consistenza di questi argomenti e nonostante l’abilità con cui il leader democristiano seppe presentarli all’opinione pubblica, la diplomazia di De Gasperi costituì l’esempio forse più grosso in tutta la storia d’Italia di subordinazione della politica estera alla politica interna, di sfruttamento della incipiente tensione nelle relazioni russo-americane per indebolire i comunisti italiani e, poiché erano loro alleati, i socialisti. Si trattò di una diplomazia che, per alcuni aspetti, era esattamente l’opposto di quella fascista. Tanto la diplomazia fascista era stata rivolta, almeno fino all’asservimento a Hitler, a cercare l’iniziativa e l’autonomia in un contesto dinamico, quanto la diplomazia post-fascista fu passiva registrazione delle direttive americane. Per altri aspetti, invece, la diplomazia post-fascista fu una prosecuzione aggiornata di quella fascista, nella misura in cui questa aveva mirato a subordinare la politica estera dell’Italia a quella di una grande potenza imperialista. In particolare, la diplomazia di De Gasperi e dei suoi successori fu vicina, pur con una ben maggiore accentuazione e unilateralità, a quella dell’era Grandi, quando l’obiettivo dell’Italia era stato quello di presentarsi come “prima della classe” al governo e alla finanza americani.
L’azionista Parri, uno dei massimi dirigenti della Resistenza, presiedette, fra il giugno e il dicembre del 1945, il primo ministero dell’Italia liberata. Fu il ministero che più di ogni altro volle trarre ispirazione dalla carica di rinnovamento morale espressa dalla Resistenza, il solo che si sforzasse di tenere presenti alcuni aspetti del nuovo stato adombrato nel CLN. I primi mesi del governo Parri furono anche il solo periodo durante il quale Togliatti prese in seria considerazione l’opportunità di attuare alcune incisive riforme economico-sociali, come la riforma agraria e una legge sui consigli di gestione nelle fabbriche. Ma Parri non fu in grado di attuare le riforme, e già alla fine di settembre cominciò a profilarsi il fallimento del suo tentativo di governo. Cadde in seguito all’opposizione dei conservatori, manifestata apertamente dal Partito liberale e subdolamente da De Gasperi, e perché alla subdola opposizione di De Gasperi si unì quella, ancor più subdola, di Nenni e, alla fine, dello stesso Togliatti. Questi, valutando realisticamente la debolezza politica del tentativo di Parri, ancora una volta intese anteporre l’alleanza con le masse cattoliche a quella col CLN.
Ma se De Gasperi, Nenni e Togliatti giuocarono Parri, fu poi De Gasperi, ininterrottamente presidente del consiglio dal dicembre del 1945 all’agosto del 1953, che giuocò Togliatti e Nenni. Per conseguire l’indebolimento delle sinistre De Gasperi cominciò nel dicembre del 1945 dando largo spazio alla presenza nel governo dei socialcomunisti e, nello stesso tempo, presentando un programma nettamente conservatore, ricalcato su quello dei liberali. In altre parole, De Gasperi rovesciò disinvoltamente, nella pratica, la definizione che egli amò dare della Democrazia cristiana: non già un partito di centro che si muoveva verso sinistra, ma un partito di centro che si muoveva verso destra. Di importanza forse decisiva per la vittoria finale della linea portata avanti da De Gasperi fu la decisione di non attribuire alla Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946, il potere legislativo, e la decisione di deferire a un referendum popolare — e non all’assemblea costituente — la scelta tra monarchia e repubblica (il 2 giugno prevalse la repubblica di misura). L’Assemblea Costituente, priva di potere legislativo, non fu in grado di introdurre riforme nell’economia, nella società, nello stato. La scelta tra monarchia e repubblica deferita al referendum consenti alla Democrazia cristiana di tenere un atteggiamento agnostico. Fu questo un fatto di grande importanza nel determinare il carattere del partito cattolico, conservatore e interclassista. Se infatti la Democrazia cristiana avesse scelto apertamente la repubblica, avrebbe perduto i suoi potenziali elettori monarchici, e i voti dei conservatori si sarebbero divisi fra la Democrazia cristiana e un partito monarchico che sarebbe sorto alla sua destra. Se, d’altra parte, la Democrazia cristiana avesse scelto apertamente la monarchia, avrebbe perduto in gran parte la sua base popolare e soprattutto il suo carattere interclassista (Baget-Bozzo).
Obiettivo principale di De Gasperi fino alla prima metà del 1947 fu di sfruttare la presenza nel governo dei comunisti e di estrometterli quando la loro presenza non avesse più costituito una utile copertura nei negoziati per il trattato di pace (che fu firmato nel febbraio del 1947) e un utile appoggio per inserire nella costituzione il riconoscimento dei Patti lateranensi (cosa che fu fatta nel marzo successivo). Un’altra considerazione ancora che indusse De Gasperi a estromettere dal governo i socialcomunisti era l’opportunità di ricuperare alla Democrazia cristiana l’elettorato conservatore del movimento dell’Uomo qualunque, giunto all’apogeo della sua forza alla fine del 1946. Inoltre la scissione socialdemocratica, effettuata da Saragat nel gennaio del 1947 in seno al Partito socialista, offrì a De Gasperi un minimo di copertura a sinistra. Non è però affatto da escludere che De Gasperi si proponesse di mantenere la collaborazione al governo coi comunisti fino a quando la costituzione non fosse stata ultimata. Ma quest’ultimo obiettivo non fu di importanza tale da imporsi sugli altri e da indurre De Gasperi a battersi a fondo per resistere alle crescenti pressioni anticomuniste esercitate su lui dal Vaticano, dagli americani e dalla Confindustria. Anzi, per quanto riguarda gli americani, le pressioni partirono proprio da De Gasperi. Le pressioni del Vaticano erano iniziate fin dal giugno del 1946, all’indomani del referendum istituzionale. Le pressioni degli americani furono contemporanee all’enunciazione, nel marzo del 1947, della dottrina Truman, con cui nasceva la guerra fredda, e furono accompagnate dalla velata minaccia che, se i comunisti non fossero stati allontanati dal governo, l’Italia sarebbe stata esclusa dagli aiuti di quello che fu poi il piano Marshall. Fu questo, a quanto pare, l’elemento decisivo che indusse De Gasperi ad allontanare dal governo i comunisti. La stessa cosa avvenne, nelle stesse settimane, in Francia.
Di fronte all’atteggiamento americano, che faceva parte di una strategia mondiale, importanza marginale, anche se da non trascurare, nel far maturare la decisione di De Gasperi ebbe l’atteggiamento di Togliatti. Questi, probabilmente per non deludere il crescente malcontento delle masse popolari, aveva adottato da qualche tempo un atteggiamento di dura opposizione contro il governo, al quale tuttavia il suo partito partecipava. Nel maggio del 1947 i socialcomunisti furono allontanati dal governo e furono chiamati a farvi parte a titolo personale alcuni liberali, fra cui Einaudi, massimo esponente del programma economico basato sulla deflazione e sulla preminenza del settore privato su quello pubblico. Tuttavia, fino al dicembre del 1947, cioè fino alla conclusione dei lavori per la costituzione, tra la Democrazia cristiana da una parte e i due grandi partiti della sinistra dall’altra continuò a sussistere un rapporto particolare. La costituzione infatti è stata il frutto di un compromesso fra questi tre partiti, cementato dall’ideologia liberale tradizionale e, soprattutto, dall’antifascismo. La validità del compromesso non è diminuita per il fatto che, al suo interno, ci furono mutamenti di posizione, dettati da mutamenti nei rapporti di forza tra lo schieramento cattolico e quello che si usa chiamare marxista. In un primo tempo i socialcomunisti, che non prevedevano l’estromissione dal governo, furono sostanzialmente critici degli aspetti della costituzione, voluti soprattutto dai cattolici, intesi a frenarne il carattere assembleare e a potenziarne quelli garantistici (in particolare l’ordinamento regionale). Ma, dopo l’estromissione dal governo, considerarono in modo positivo tutto l’impianto garantistico.
Nel dicembre del 1947, terminati i lavori della costituzione, terminò anche il rapporto particolare tra la Democrazia cristiana e i socialcomunisti. De Gasperi si alleò con i partiti minori laici (il socialdemocratico, il repubblicano e il liberale) e ebbe cura di contenere le spinte, sempre presenti nel mondo cattolico e nel Vaticano, verso la destra clericale; ma ebbe soprattutto cura di esercitare una costante pressione sui due grandi partiti della sinistra e sul loro sindacato, la CGIL, non esitando, per ottenere questo scopo, a sabotare l’applicazione delle norme garantistiche previste dalla costituzione (corte costituzionale e regioni) e a predisporre nel 1953 una nuova legge elettorale maggioritaria (la “legge truffa,” come la chiamarono le sinistre) che avrebbe dovuto praticamente emarginare dal sistema l’opposizione, cioè i socialcomunisti.
In sostanza De Gasperi mirò a creare un tipo di stato che si avvicinasse il più possibile al vecchio stato liberale oligarchico (naturalmente nel contesto di una realtà contrassegnata dalla presenza attiva delle masse). È indicativa, a questo proposito, la scarsa sensibilità di De Gasperi per i problemi del partito, che per lui non fu altro che un insieme di notabili appoggiati dall’apparato organizzativo della chiesa. Già abbiamo paragonato la maggioranza di governo democristiana alla maggioranza di governo giolittiana. Questo paragone, se è giustificato dal fatto che il liberalismo giolittiano, pur separato dalla cesura del fascismo, è cronologicamente il più vicino al liberalismo degasperiano, non tiene però conto del fatto che De Gasperi mirò a creare una concentrazione di borghesia, ceti medi e contadini a carattere sostanzialmente antioperaio, mentre invece Giolitti aveva considerato, soprattutto nella prima parte del suo periodo, il movimento operaio uno dei suoi interlocutori privilegiati. […]
Sotto alcuni aspetti De Gasperi sembrava addirittura riallacciarsi alla destra storica, alla tendenza a privilegiare la funzione coercitiva dello stato, a dirigere il paese dall’alto, con una formula di governo (il centrismo) rigida, intesa più ad escludere che non ad assorbire nella maggioranza parlamentare le forze presenti nel paese. Ciò che rendeva possibile questa formula di governo era l’anticomunismo, che si rivelò un cemento aggregante di forze diverse più forte di quanto non fosse stato il trasformismo di Depretis e di Giolitti. Ma se l’anticomunismo ebbe questa funzione “positiva”, aggregante, che rese in qualche modo la maggioranza di governo di De Gasperi analoga a quella della destra storica, analoghi ne furono anche i limiti, e cioè una sorta di malthusianesimo politico che impediva alle due maggioranze (della destra storica e di De Gasperi) di adeguarsi progressivamente al crescere delle richieste del paese. […]
La corrente di sinistra [della DC, ndr], capeggiata da Dossetti, si era costituita nel dicembre del 1946 per reagire alla sempre più chiara tendenza di De Gasperi intesa, in una prospettiva più o meno ravvicinata o lontana, ad estromettere le sinistre dal governo. La corrente di sinistra, invece, si dichiarava sostenitrice convinta della collaborazione fra i tre partiti di massa. […] In seguito una parte della sinistra subì una trasformazione, il cui massimo esponente fu Fanfani. Fra il 1954 e il 1959 questi, in qualità di segretario della Democrazia cristiana, non mirò più tanto alle riforme quanto alla creazione vera e propria e al potenziamento del partito, inteso come organismo di massa a direzione burocratica e base clientelare. Nacque così nella Democrazia cristiana un secondo, decisivo modo di ottenere il consenso nel paese, accanto a quello costituito dalla corrente di sinistra: un modo burocratico-clientelare, di cui Fanfani è diventato il massimo rappresentante e che ha fortemente inquinato la sinistra [della DC, ndr].
Perfettamente omogenea al modello di stato di De Gasperi fu la politica economica dei ministeri da lui presieduti dopo l’allontanamento dei socialcomunisti, una politica che mirò a superare la crisi postbellica, l’inflazione e il deficit del bilancio unicamente con la restrizione del credito e degli investimenti. Questa politica indebolì la forza contrattuale dei sindacati, favorì i ceti medi e i contadini e spianò la strada alla grande vittoria elettorale del 18 aprile 1948 [vittoria che oggigiorno anche la storiografia e la stampa reazionarie ammettono essere frutto di brogli e di interventi stranieri, della CIA: https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2014/06/29/news/italia-1948-fu-la-cia-1.35749190, ndr]. Rispetto alle precedenti elezioni politiche del 2 giugno 1946 per la Costituente, la Democrazia cristiana avanzò dal 35% al 48,5%, i socialcomunisti arretrarono dal 40% al 31%.
Per la sinistra la giornata del 18 aprile fu la conferma che la politica di Togliatti aveva sopravvalutato la consistenza elettorale dei socialcomunisti, che questi erano meno forti della Democrazia cristiana. Era la definitiva messa in crisi del programma di democrazia progressiva, che il Partito comunista dovette abbandonare per far argine contro l’offensiva conservatrice. Dopo il 18 aprile De Gasperi preparò anche, per la facciata, un programma di riforme, necessarie per modificare lo stato ereditato dal fascismo e per applicare la costituzione repubblicana: riforma della pubblica amministrazione, della scuola, tributaria, agraria, ordinamento regionale. Ma di questo programma furono attuati solo due stralci, destinati a restare asfittici: la riforma agraria Segni e la cosiddetta imposta Vanoni. Non c’era posto per le riforme in un programma che perseguiva la restaurazione del capitalismo classico. Per motivi analoghi fu lasciato cadere il piano quadriennale per il 1948-1952 di Saraceno e fu respinto il già ricordato piano del lavoro della CGIL. L’offensiva conservatrice fu singolarmente favorita non solamente dalla restaurazione capitalistica ma anche, nel corso degli anni Cinquanta e soprattutto nella loro seconda metà, da una congiuntura internazionale eccezionalmente favorevole, iniziata con la guerra di Corea, dalla quale seppero trarre profitto particolare quelle economie, come la tedesca e l’italiana, che erano state ricostruite dopo la guerra lasciando la più ampia libertà al padronato.
L’industria italiana si mosse dopo quella tedesca ma ebbe una crescita di proporzioni tali come mai si era avuta in precedenza. Fra il 1950 e il 1961 l’incremento medio annuo del reddito nazionale è stato del 6,1%, superato nell’Occidente capitalistico solo da quello tedesco col 7,5%. Il reddito reale pro capite è triplicato in Italia fra il 1861 e il 1961, ma più della metà dell’incremento si concentra nel decennio 1951-1961. Gli aiuti finanziari forniti dagli Stati Uniti col piano Marshall, anche se accettati dal governo italiano con parsimoniosa cautela per timore di rompere il quadro deflazionistico e restrittivo, frenarono alcuni effetti negativi di quest’ultimo e sollevarono l’economia italiana e europea da quella deficienza di capitali che l’aveva così profondamente turbata dopo la prima guerra mondiale.
Fu uno sviluppo industriale di tipo estensivo, favorito dal mercato estero che “tirava” e dalla grande elasticità del mercato interno della forza-lavoro; uno sviluppo nel quale trovarono posto non solo ogni tipo di industrie, soprattutto quelle che lavoravano per l’esportazione — dalle grandi concentrazioni a una miriade di medie e piccole aziende — ma anche la rendita. In particolare la rendita delle aree edificabili urbane che, legata all’edilizia, ebbe una rilevante funzione propulsiva. Un altro tipo di reddito che, in modo improprio, si suole assimilare alla rendita, quello fornito dalla spesa pubblica per il tramite del sottogoverno e del clientelismo burocratico, trovava ampi margini per proliferare, singolarmente agevolato dal partito dominante di governo, quale Fanfani lo andava organizzando, che divenne il tramite principale di un triangolo costituito dallo stato, dalle aziende pubbliche e dalle grandi aziende private. In linea di principio la spesa pubblica non avrebbe dovuto più tanto servire a sostenere il settore privato, che camminava da sé grazie alla eccezionale congiuntura, quanto a finanziare obiettivi di natura sociale o intesi a rimuovere gli squilibri. In pratica, però, il privatismo dominante rendeva inefficienti questi interventi, la cui principale finalità reale divenne quella di finanziare la classe di governo, e in particolare il partito democristiano, a fini clientelari ed elettoralistici.
La conseguenza sul piano politico-sociale del boom economico fu, a differenza di quanto era avvenuto negli anni immediatamente successivi al 1896, non tanto una crescita relativamente autonoma di un nuovo ceto imprenditoriale quanto una concentrazione dei ceti medi intorno ai gruppi dominanti, una alleanza del profitto con la rendita fondiaria urbana e con la spesa pubblica improduttiva a fini clientelari, alleanza fatta comprimendo i salari e accentuando lo sfruttamento operaio, ma estendendo altresì l’occupazione. Causa principale della mancata autonomia del nuovo ceto imprenditoriale fu il ruolo centrale che continuava a svolgere, come al tempo del fascismo, lo stato nel promuovere lo sviluppo, dominato dai gruppi privati che venivano ad esercitare un potere pubblico.
Il boom economico rovesciò, per molti aspetti anche se non per tutti, l’ipotesi di Togliatti di una concentrazione dei ceti medi e della classe operaia. Si affermò in Italia il consumismo di massa che tendeva ad integrare, sotto il diluvio delle automobili e degli elettrodomestici, la classe operaia nei ceti medi. I ceti medi, quanto meno quelli delle regioni centro-settentrionali, cessarono di sentirsi esclusi dalle tradizionali intese fra industriali e operai, di farne le spese; e si sentirono inseriti nello sviluppo industriale in misura ben maggiore che in passato. Naturalmente questo si riferiva solo ad una parte dei ceti medi, a quelli moderni, amministratori dei servizi richiesti dallo sviluppo. Questo tipo di integrazione non si riferiva alla parte dei ceti medi, tradizionalmente grossa in Italia, non inseriti o non inseriti con funzione positiva nel sistema produttivo, né si riferiva agli studenti. Tuttavia i ceti medi non inseriti nel processo produttivo, diffusi soprattutto al Sud, trovarono margine di integrazione nel sistema grazie alla spesa pubblica a scopi clientelari.
I monopoli affermarono la loro capacità di integrarsi, quanto meno tendenzialmente, l’intera società, di imprimerle il modello della loro sostanza autoritaria. Se il fascismo era stato una specie di scorciatoia per conseguire, in misura ben più accentuata, risultati analoghi, la sua ipotesi diventava adesso meno idonea al paese, che non pareva aver più bisogno di questa scorciatoia. Rispetto al ventennio fascista, il paese risultava cresciuto sia economicamente che politicamente: economicamente, perché i monopoli sembravano in grado di integrarsi le masse, con la forza certo determinante dello stato, ma non nei modi e nella misura che questa forza aveva assunto nel fascismo; politicamente, perché, grazie alla Democrazia cristiana, esisteva adesso un partito conservatore in grado di ottenere il consenso delle masse senza dover sovvertire l’ordinamento politico e sopprimere tutte le libertà. In passato i tradizionali lamenti dei conservatori per il prevalere del parlamento sull’esecutivo, delle minoranze sulla maggioranza, dei partiti sullo stato erano sfociati nel fascismo, cioè nella sovversione del parlamento e del regime liberale. Adesso le aspirazioni conservatrici trovavano finalmente alleati potenti nella realtà oggettiva del paese. Diventava possibile un disegno reazionario conservatore in grado di usare e di padroneggiare la sovversione, senza dover seguire fino in fondo la via, che il passato dimostrava carica di rischi, della reazione sovversiva.
Sebbene l’eccezionale crescita economica sembrasse risolvere tutti i problemi, in realtà questi sono stati solo momentaneamente accantonati e, intorno al 1960, si sono riproposti, ingigantiti dallo stesso sviluppo. Si trattava e si tratta di una serie di “strozzature” che hanno il loro fondamento nel dualismo dell’economia italiana, nell’accentuato dislivello fra i settori in espansione e quelli in ristagno, tra il settore privato e quello pubblico, tra l’industria dinamica che produce anche per l’esportazione e quella stagnante che produce solo per il mercato interno, tra l’industria e l’agricoltura, tra il Nord e il Sud. Si trattava e si tratta, in parte, di problemi comuni a tutto il mondo capitalistico e industrializzato. Ma il carattere lacerante del boom è stato particolarmente violento in Italia perché accentuato dagli squilibri economico-sociali tipici del nostro paese. Si pensi alla questione meridionale. Si pensi che il massiccio intervento pubblico, rigidamente subordinato al settore privato, esalta il dualismo fra i monopoli e la piccola e media industria, insieme agli squilibri territoriali; e che questi effetti negativi dell’intervento pubblico sono tanto maggiori quanto più intenso è lo sviluppo (sono stati maggiori nel 1915-1918 e nel 1954-1962 che durante il fascismo).
Dicevamo che i ceti medi si sono integrati nella società industriale consumistica; e dicevamo anche che questa integrazione non è stata priva di limiti. Il principale di questi limiti, che genera forti tensioni sociali, è forse quello provocato dallo squilibrio tra la crescente scolarizzazione e l’incapacità del sistema di fornire scuole adeguate agli studenti e adeguati posti di lavoro ai laureati e diplomati. Ciò frena l’integrazione dei ceti medi e anzi contribuisce a creare uno stato di frustrazione che ha in Italia, come sappiamo, un ricco passato. Inoltre — dicevamo — uno dei canali di integrazione dei ceti medi nel sistema è stata la spesa pubblica a scopi clientelari. L’integrazione dei ceti medi, per questo aspetto, è avvenuta accentuando il loro parassitismo.
Il boom degli anni Cinquanta non ha riguardato l’agricoltura. Nel 1950-1961, mentre l’incremento medio annuo del reddito nazionale dell’industria è stato del 7,6% e quello del terziario è stato del 7,5%, quello dell’agricoltura è stato solamente dell’I% (Saraceno). Alla base dello squilibrio sta il fatto che i prezzi del commercio e quelli dell’industria sono aumentati più di quelli agricoli. È continuata, accentuandosi, la forbice tra prezzi industriali e prezzi agricoli iniziata nel ventennio fra le due guerre. Inoltre i costi della intermediazione commerciale (talora una vera e propria rendita, che si allinea accanto a quella delle aree urbane e a quella burocratica) incidono molto più sull’agricoltura che non sulla industria. Nel contesto di una agricoltura in crisi e incapace di ammodernarsi e razionalizzarsi, il rapido esodo dalle campagne (la percentuale dei contadini sulla popolazione attiva è scesa fra il 1951 e il 1961 dal 40% al 20% ), che ha aumentato i costi della mano d’opera e ha provocato l’abbandono di molte terre, è stato un ulteriore, fondamentale elemento di crisi. La crisi agraria e l’esodo dalle campagne hanno colpito in misura particolare le zone collinari di tutta la penisola e il Mezzogiorno nel suo complesso. Anche al Sud c’è stata una fuga dalle campagne alle città. Ma qui l’esodo dalle campagne ha assunto la forma tradizionale della emigrazione.
Tuttavia anche nella emigrazione c’è stata una novità di grande rilievo perché, in buona parte, il flusso migratorio non si è più diretto all’estero ma, soprattutto dopo il 1960, nelle città industriali dell’Italia settentrionale. Per questo aspetto, l’emigrazione ha cessato di essere una perdita netta di risorse della nazione. Ma ha anche cessato di essere una valvola utile per allentare le tensioni sociali e creare una maggiore disponibilità di terra a favore dei contadini rimasti nel Sud; anzi, ha accentuato gli squilibri fra Nord e Sud, contribuendo alla crescita caotica e congestionata delle città settentrionali, e contribuendo altresì a fare un deserto di larghe estensioni del Sud. Forse mai come in questo ultimo ventennio il Mezzogiorno ha svolto, nella economia dello stato unitario, un duplice ruolo: dinamico nel breve periodo, di freno nel lungo periodo. In una prima fase ha favorito lo sviluppo, rifornendo l’industria settentrionale di mano d’opera; nella fase successiva è diventato, come mai prima, “la strozzatura maggiore che si frappone allo sviluppo dell’intero paese.”
Si è ripetuto, su scala maggiore, il consueto fenomeno che la modernizzazione del Settentrione accentua la disgregazione del Mezzogiorno perché mette in crisi i vecchi rapporti sociali senza crearne di nuovi. Non a caso la mafia ha conosciuto due epoche di particolare diffusione: dopo l’avvento della sinistra storica al potere nel secolo scorso [del XIX sec, ndr] e, in misura ben maggiore, ai giorni nostri, nei quali le forme nuove assunte, lo scarso senso dello stato del partito di governo democristiano e forse l’intreccio con forze politiche interessate strumentalmente alla sovversione reazionaria le hanno consentito di diffondersi addirittura a livello nazionale. Allo schema di uno sviluppo graduale ed equilibrato, nel quale la crescita dell’industria fosse associata e seguisse all’ampliamento del mercato interno, si è contrapposta la realtà di uno sviluppo tumultuoso e squilibrato, “tirato” dall’industria. È scomparso l’antico male meridionale della pressione contadina sulla terra, ma è rimasta la conseguenza di quel male, cioè l’immobilismo: non più tanto l’immobilismo di una società patriarcale ed arretrata quanto l’immobilismo di un deserto, punteggiato qua e là dallo sviluppo di alcune oasi e dalla diffusa frustrazione di ceti medi e popolari.
Come già abbiamo accennato, all’inizio degli anni Cinquanta la Democrazia cristiana ha fatto una parziale riforma agraria per tagliare le ali al movimento contadino nel Sud (del resto già in deflusso) e cacciare i comunisti dalle posizioni conquistate. La riforma agraria ha avuto un costo politico pesante per la Democrazia cristiana perché le ha fatto momentaneamente perdere le simpatie elettorali dei conservatori meridionali, causa, a quanto pare, del fallimento della “legge truffa” nel 1953. Ma la riforma agraria, pur eliminando definitivamente il tradizionale potere dei latifondisti, già messo in crisi dalla guerra, non ha saputo creare un nuovo ceto vitale di contadini proprietari ed ha anzi avviato la premessa della accentuata disgregazione sociale provocata poi dal “miracolo economico.” È proprio su questo mancato rinnovamento che ha fatto leva la Democrazia cristiana per riconquistare le sue posizioni di potere. La organizzazione del partito democristiano ad opera di Fanfani dopo il 1954 è stata in misura cospicua un fatto che ha riguardato il Mezzogiorno. La Democrazia cristiana ha ricreato il sistema clientelare, rotto negli anni precedenti dal movimento contadino, su basi nuove, i cui elementi portanti non sono più i notabili ma il partito e la sua burocrazia (più diffusa al Sud che al Nord), il sotto-governo e la Cassa del Mezzogiorno.
Da allora il Sud è tornato ad essere, secondo la tradizione, più legato del Nord al partito di governo; e, quando ha fatto della fronda o della opposizione, questa è stata di destra, sebbene dalla Democrazia cristiana meridionale sia pressoché assente l’ala di sinistra. Da allora il Mezzogiorno ha cessato di essere, come era stato per alcuni anni dopo il 1945, soggetto del dibattito politico in una prospettiva di rinnovamento democratico, e, come al tempo del meridionalismo liberale, è tornato ad essere semplice oggetto di quel dibattito, problema da affrontare con interventi dall’alto più o meno efficaci. Si è trattato e si tratta, nelle intenzioni, di prendere coscienza del carattere nazionale della questione meridionale, nel senso che il mancato sviluppo del Sud frena ormai lo sviluppo del Nord. Si è trattato e si tratta, nelle intenzioni, di approntare un insieme di interventi pubblici capaci di frenare e invertire la tradizionale tendenza spontanea delle forze del mercato, per la quale la crescita economica si concentra nel Nord e si traduce in un impoverimento — assoluto o relativo — del Sud; di creare nel Sud una base industriale in grado di offrire lavoro a chi non ne trova nell’agricoltura e in grado di mettere in moto un autonomo meccanismo di sviluppo basato sul mercato (Saraceno).
A tale scopo (e allo scopo di consolidare le posizioni di potere della Democrazia cristiana) è stato istituito nel 1950 un ente apposito, la Cassa del Mezzogiorno. Ma questa, fino agli inizi degli anni Sessanta, si è limitata a fare, pur potenziandola, la tradizionale politica dei lavori pubblici per migliorare o creare le cosiddette infrastrutture. Gli aumentati interventi pubblici a favore del Sud si sono risolti in un beneficio soprattutto per il Nord, perché la domanda addizionale di prodotti industriali, provocata nel Sud dalla spesa pubblica, ha trasferito questa al Nord (Saraceno). Lo squilibrio tra Nord e Sud, anziché diminuire, è aumentato.
Fonte: Giampiero Carocci, Storia dell’Unità d’Italia ad Oggi, Feltrinelli, Milano, 1975
Introduzione e redazione a cura di Luscino

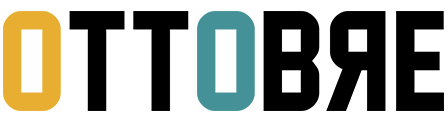







[…] [2] Cf. la nostra serie storica sul capitalismo italiano disponibile qui https://ottobre.info/2020/06/15/la-ricostruzione-capitalistica-e-il-miracolo-economico-al-principio-… […]