Quello che vi presentiamo qui è uno scritto di Giampiero Carocci, storico borghese di formazione gramsciana. Lo scritto è l’introduzione ad un’opera più ampia, Storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri, del 1975, ed è una interessante ricostruzione delle origini del capitalismo italiano e delle specificità del suo sviluppo, delle arretratezze, del frazionamento di esso e della borghesia. Inoltre a ciò aggiunge un confronto con le diverse tipologie di sviluppo del capitalismo in altri paesi europei (Inghilterra, Francia, Germania) delle quali l’autore ravvisa elementi presenti, in varia misura, nello sviluppo di quello italiano. Una stimolante narrazione in piena ottica storico-materialista che vale la pena di essere riproposta.
*************
Nello studiare i diversi modi, le diverse “vie” attraverso cui i paesi dell’Europa occidentale e centrale sono passati, durante l’età moderna fra il Quattrocento-Cinquecento e il Settecento-Ottocento, dal feudalesimo al capitalismo, gli storici hanno individuato tre paesi nei quali quel passaggio ha assunto caratteri particolarmente marcati e tipici: l’Inghilterra, dove c’è stato un impetuoso sviluppo borghese, mercantile coloniale e poi industriale, dove anche i signori feudali si sono trasformati in imprenditori borghesi e dove i contadini sono stati ridotti a lavoratori salariati ovvero, espulsi dalle campagne, sono stati assorbiti nel commercio, nelle industrie, nelle colonie (la “via inglese”); la Prussia, dove i signori feudali, pur restando tali e pur continuando a godere dei loro privilegi, hanno trasformato le loro terre in aziende capitalistiche, la cui forza-lavoro era fornita dai contadini, ridotti in condizioni semi-servili (la “via prussiana”); la Francia, dove i signori feudali sono sempre stati fronteggiati da un ceto vigoroso di contadini proprietari e sono stati poi spazzati via da una rivoluzione politica (la “via francese”).
In Italia, come del resto in altri paesi, si sono avuti, in diversa misura e diversamente combinati, elementi di tutte e tre quelle “vie”. Ma una prima peculiarità del nostro paese sembra il fatto che nessuno di quegli elementi sia stato capace di imporsi sugli altri e di dare cosí luogo a uno sviluppo coerente; il fatto che il feudalesimo né si è evoluto in senso liberale all’inglese o conservatore-reazionario alla prussiana, né è stato distrutto da una rivoluzione. I secoli del passaggio dal feudalesimo al capitalismo in Italia sono caratterizzati da una lotta delle classi, intesa come fatto continuo, meno intensa che altrove. Non ci furono né i contrasti francesi fra signori e contadini, né il travolgente sviluppo capitalistico che in Inghilterra contrappose precocemente borghesi proletariato; né, d’altra parte, la meno intensa lotta di classe era dovuta, come in Prussia, a una completa subordinazione del contadino allo Junker.
Limitiamoci ad alcuni esempi. La società piemontese dell’ancien régime ricordava quella francese per la presenza di un ceto feudale e di una diffusa, vitale proprietà contadina; ma non ci fu mai la scossa rivoluzionaria che ci fu in Francia. La nobiltà piemontese gretta, fedele al suo re e alle imprese militari, ricordava anche quella prussiana; ma vari fattori, tra cui la presenza della proprietà contadina, impedirono che si realizzasse la “via prussiana”. Nella Valpadana irrigua alcuni grandi proprietari e gli affittuari sembravano imitare i loro colleghi inglesi, ma la mancanza di un ambiente mercantile e manufatturiero in forte espansione impedì che si traducessero nella “via inglese”. Il libero commercio del grano introdotto in Toscana nel Settecento sembrava aprire ai grandi proprietari una prospettiva sia prussiana che inglese; ma la imperante mezzadria, garantendo una facile rendita e ostacolando la razionalizzazione del modo di produzione, tolse a costoro l’incentivo a trasformarsi compiutamente in imprenditori. Nelle campagne meridionali numerosi erano gli elementi di tipo prussiano. Ne vedremo più avanti gli sviluppi ed i limiti.
Sulle cause di questa peculiarità italiana, di questa situazione di stallo, io non sono in grado che di avanzare due ipotesi. Una prima causa consisterebbe nella mancata unificazione nazionale e nelle diverse tradizioni storiche delle sue regioni, in quel particolarismo sul quale di recente è tornato Galasso. Una seconda causa consisterebbe nel fatto che ciascuna delle tre “vie” presupponeva l’esistenza di un ceto feudale forte, attivo nella difesa dei suoi privilegi o nella ricerca del profitto o in entrambi gli scopi. Ciò non è avvenuto in Italia, paese a netta prevalenza cittadina, dove il feudalesimo, pur particolarmente persistente, è stato però debole.
Questa ipotesi che vede nella scarsa vitalità del feudalesimo una causa di debolezza può parere paradossale, quando si tenga presente che proprio il fatto di aver avuto un feudalesimo debole e, per converso, di essere stata il paese delle città ha procurato all’Italia la gloria del capitalismo precoce e della civiltà comunale e rinascimentale. Ma il capitalismo precoce non è stato in grado dí trasformarsi in capitalismo moderno. L’Italia non è stata l’Olanda. Vero che in Italia l’alta tradizione civile delle città non si è mai cancellata. Ciò non toglie però che il particolarismo cittadino, da motivo di forza che era stato, si trasformò in motivo di debolezza, dopo il Cinquecento, quando il problema politico centrale in Europa diventò quello della creazione o del consolidamento dello stato nazionale o ad ampia base territoriale, per il quale non era sufficiente la proiezione della città sul circostante territorio regionale.
Il feudalesimo italiano, fin dalle sue origini, ha avuto la tendenza a polverizzarsi, è stato incapace di creare una salda organizzazione gerarchica della società. È mancata nella maggior parte delle campagne italiane la presenza del signore, sia pur sfruttatore, ma creatore intorno alla sua persona e alla sua famiglia di una stabile aggregazione di ceti subalterni. È vero che nel Mezzogiorno il feudalesimo è stato forte; ma nemmeno qui esso ha funzionato da centro aggregatore, per vari motivi, fra cui il carattere non nazionale della monarchia. Il feudalesimo, debole sotto il profilo giuridico-istituzionale, è stato però forte e persistente sotto il profilo economico-sociale: non tanto per sua intrinseca vitalità quanto per la debolezza dell’azione antifeudale dei ceti di nuova borghesia.
La sua caratteristica fondamentale, aggravata nel Seicento dalla cosiddetta rifeudalizzazione, soprattutto nei domini spagnuoli e nello stato della Chiesa, è stato l’assenteismo del signore che spendeva in città la rendita: nelle città di tipo municipale-corporativo del Centro-Nord e nelle due grandi capitali parassite — Napoli e Palermo — del Sud. Il feudalesimo, anziché essere un contrappeso, ha ribadito la caratteristica italiana della subordinazione della campagna alla città, della separazione fra contadini e proprietari. In questa subordinazione, in questa separazione sta la radice della debolezza dei conservatori e della scarsa egemonia che la classe dirigente avrà nello stato unitario: una classe dirigente priva di quei legami col popolo, e in particolare coi contadini, che sono tipici di un persistente feudalesimo di tipo prussiano o del suo mutarsi in senso liberale di tipo inglese, ovvero della sua distruzione rivoluzionaria come in Francia.
In un simile contesto anche l’avanzare nel Settecento del capitalismo nelle campagne e il conseguente peggioramento delle condizioni dei contadini approfondivano la divisione fra questi e i proprietari senza dar luogo a vincoli di tipo nuovo. Solo in poche zone la mancanza di legami organici fra le classi presentava delle eccezioni. La più importante di queste era costituita dal Piemonte dove, in contrasto con la tendenza generale nella penisola alla polarizzazione tra grande e piccola proprietà, le proprietà nobiliari erano di media grandezza, scarso era l’assenteismo dei proprietari, diffusa e vitale era (come abbiamo detto) la piccola proprietà, vigorose l’autorità regia e la presenza dello stato che abolirono i privilegi feudali. Anche in Toscana l’assenteismo dei proprietari era scarso e la mezzadria costituiva un efficace strumento di egemonia, pur se il suo risvolto era la tendenza all’immobilismo economico e sociale. Dopo l’unità un altro importante strumento di egemonia dei proprietari toscani furono i rapporti col clero, che rimasero particolarmente intimi. Ma il Piemonte e, in minor misura, la Toscana (e forse anche il Veneto, dove il cattolicesimo ebbe effetti sociali di tipo “prussiano”) erano eccezioni, isole di coesione sociale in un mare il cui carattere fondamentale era la mancanza di saldi legami fra i ceti proprietari e quelli popolari.
Come già abbiamo ricordato, Gramsci ha definito il Mezzogiorno una grande disgregazione sociale. Il giudizio è particolarmente calzante per il periodo che inizia col secolo XIX e soprattutto negli anni Ottanta. Ma la sostanza di questo giudizio affonda le sue radici nel corso del secolo XVIII, col processo di erosione del feudalesimo, di privatizzazione e concentrazione della terra, di avanzata del capitalismo: tutti fatti che accentuarono la pressione dei contadini sulla terra e il loro rapporto con questa precario e disperso. Inoltre quel giudizio di Gramsci si estende anche a taluni aspetti dell’Italia intera: alla vita precaria del bracciante padano, all’ostacolo che i ceti cittadini opponevano contro un aggregarsi moderno, non corporativo della società, e infine, dopo l’unità, al carattere eterogeneo delle due Italie, la meridionale e la centro-settentrionale.
L’insufficiente disponibilità di terra nel Mezzogiorno non solo peggiorava le condizioni dei contadini dipendenti ma metteva in crisi (soprattutto, è vero, dopo il 1880) i piccoli proprietari, alcuni dei quali decadevano a proletari e altri infoltivano la schiera dei piccolo-borghesi disoccupati. Quest’ultimo era l’aspetto meridionale di un analogo fenomeno del Centro-Nord, provocato dalla secolare decadenza dei ceti medi cittadini. Questo processo di declassamento, dovuto al fatto che i ceti medi e i contadini, nella misura in cui non acquistavano caratteri moderni, erano più numerosi, in campagna e in città, di quanti il sistema ne potesse assorbire, si accentuò dopo l’unità e divenne uno dei problemi di fondo dello stato italiano.
In astratto, il mezzo per frenare lo squilibrio tra la disponibilità di terra e il numero dei contadini e per consentire lo sviluppo capitalistico delle campagne meridionali sarebbe stata la creazione di un ceto vitale di contadini proprietari, con una rivoluzione o di riforma agraria — limitata a questa parte d’Italia — durante il Risorgimento (Tosi). Ma ciò era problematico perché (la situazione ricordava quella della Spagna) le terre appartenevano non solo alla nobiltà ma, in simbiosi con questa, anche alla borghesia e alla nobiltà imborghesita, che fornivano il grosso delle forze liberali. In sostanza, ciò che rese impossibile la “via francese” fu la scarsa forza, sia del feudalesimo che dello sviluppo capitalistico: la scarsa forza di questi due fattori aveva favorito prima il penetrare e poi il ristagnare della borghesia nella proprietà della terra. Anche i provvedimenti che, prima e soprattutto dopo l’unità, furono presi con l’intento di creare o di consolidare la proprietà contadina (quotizzazione dei demani comunali e vendita dei beni ecclesiastici) si risolsero nell’effetto opposto di ingrandire le proprietà esistenti. La pressione dei contadini sulla terra, i rapporti sociali tradizionali, lungi dal risultarne mutati ne furono confermati.
Si manifestava qui l’aspetto particolare, contadino, meridionale di un fenomeno che affondava le sue radici anche nella tradizione cittadina italiana: quel carattere economico-corporativo dei comuni, osservato da Gramsci, per cui le innovazioni introdotte nella vita comunale non ruppero i rapporti di produzione feudali ma vi si integrarono, diedero poi luogo alla “peggiore delle forme di società feudale, la forma meno progressiva e piú stagnante”, e si cristallizzarono in oligarchie immobiliste e in una sonnolenta “borghesia rurale”. Fu il modo — non popolare e non nazionale — col quale si è stabilizzato in Italia l’ancien régime nei secoli di trapasso dal feudalesimo al capitalismo.
La generale tendenza e capacità, che caratterizzerà la storia dello stato unitario, delle forze dominanti (vero e proprio surrogato della egemonia) a soffocare le forze nuove man mano emergenti per lo sviluppo, a togliere loro l’autonomia, a integrarsele, cui si accompagnerà la presenza, determinante in ogni attività imprenditoriale, della rendita, variamente combinata col profitto, insomma il sorgere dello sviluppo capitalistico da rapporti semifeudali avvicinavano in misura singolare la realtà italiana a quella prussiana. La somiglianza era ribadita dal fatto che sia in Germania che in Italia la frazione conservatrice del blocco di potere, quella dei proprietari terrieri, dominava una parte ben definita del territorio nazionale (la Prussia a est dell’Elba, il Mezzogiorno), con sue precise tradizioni storiche, e ciò aumentava la forza dei proprietari. Tuttavia accanto alle analogie c’erano, piú importanti, le differenze. L’egemonia dello Junker prussiano sui contadini, sfruttati ma diretti, la sua posizione dominante — anche se contrastata nell’impero tedesco – derivavano dalle sue capacità imprenditoriali, burocratiche, militari. Il proprietario italiano meridionale era invece — spesso anche se non sempre — assenteista e, nella compagine del nuovo stato, fu un rimorchiato rispetto ai gruppi colti, attivi e moderni di borghesia e di nobiltà imborghesita settentrionali.
È vero però che anche nello stato unitario tedesco, come in quello italiano, violente furono le spinte tra forze contrastanti, generatrici di una pericolosa fragilità di fondo dello stato guglielmino, ereditata poi dalla repubblica di Weimar e dal regime nazista. La matrice reazionaria dello stato diede luogo nell’impero tedesco a un meccanismo elettorale e istituzionale che, collocando le sinistre in un ghetto politico, impedì una dialettica reale tra queste ultime e i conservatori. Tuttavia i contrasti esistenti nell’Italia unita, l’incapacità dei conservatori a esercitare in modo stabile e continuo la loro direzione sul paese sembravano piuttosto avvicinare la situazione italiana a quella francese.
Ma anche qui, accanto alle analogie, c’erano, piú importanti, le differenze. La minore omogeneità della società francese rispetto a quella inglese o anche a quella tedesca era dovuta alla rivoluzione politica, che aveva rotto la continuità storica della classe dirigente. Nulla di questo in Italia, dove la rivoluzione, attiva nel Risorgimento e ricca di conseguenze sul piano politico, fu però quasi inesistente sul piano sociale. Quella tradizionale scarsa vivacità della lotta di classe, cui abbiamo accennato, consentì nel Risorgimento ai moderati una politica nazionale unitaria che sfruttò e, insieme, contenne la rottura rivoluzionaria. Alla base di tutto questo stava il fatto che i protagonisti del Risorgimento, a parte alcune eccezioni (la piú importante delle quali è costituita da Cavour), erano tutto sommato scarsamente sensibili, pur senza scartarlo dal loro orizzonte, a quell’insostituibile elemento dinamico e unificatore che è lo sviluppo economico. L’elemento unificatore fondamentale — vero e proprio surrogato — fu la cultura. Un fatto analogo si ebbe nelle società economicamente arretrate della Russia e dell’Europa danubiana. Ma forse in Italia fu particolarmente accentuato perché affondava le sue radici lontano nei secoli precedenti e perché si accompagnava in misura minore che in molti di quei paesi a una sensibilità per i problemi della società (si pensi alla Russia) o della lotta contro la dominazione straniera (si pensi alla tradizione serba).
In Italia la preminenza della cultura fu comunque un fatto di grande importanza durante il Risorgimento. Dopo secoli di arcadia e di torre d’avorio, la cultura tornava ad essere sentita nel suo valore più profondo, come fatto civile. Ciò avvenne per merito dei ceti colti che diressero il Risorgimento e, conseguita l’unità, costituirono del partito moderato, al potere fino al 1876. Ma se avere saputo realizzare l’unione — sempre così rara, soprattutto in Italia — di potere e di cultura costituisce una gloria dei moderati, la preminenza della cultura a danno della economia ebbe anche un grave aspetto negativo: il fatto, cioè, che il liberalismo risorgimentale non fu l’ideologia di una classe bensì solo di alcuni intellettuali borghesi o aristocratici imborghesiti. L’opposto avvenne in Germania, dove il periodo della unificazione coincise con quello della industrializzazione e dove i liberali, inizialmente ostili a Bismarck ma favorevoli all’unità nazionale in gran parte per motivi economici, accettarono la politica unificatrice della Prussia e sacrificarono il liberalismo alle esigenze dello sviluppo economico.
Gli squilibri di fondo della società tedesca, il carattere corporativo della sua vita politica furono determinati dall’impetuoso sviluppo economico, dalla sua preponderanza sullo sviluppo civile e politico. In Italia gli squilibri di fondo e le spinte corporative furono determinati da motivi opposti. L’economia e la guerra, che furono i due fattori fondamentali dell’unificazione tedesca (Zollverein, guerre del 1866 e del 1870), ebbero un ruolo secondario o marginale nell’unificazione italiana. Per la verità, la guerra svolse un ruolo di rilievo anche nel Risorgimento italiano. Ma con due caratteri peculiari. Il primo è che la guerra, in se stessa, sarebbe stata inefficace se non fosse stata associata alla diplomazia, perché il Piemonte, da solo, non sarebbe stato in grado di vincere l’Austria. Il secondo carattere è che in Piemonte (come poi nell’Italia unita) non c’era, come ha notato Pischedda, l’uguaglianza dei ricchi e dei poveri di fronte al servizio militare, che era tipica della Prussia. Solo in parte nella società piemontese la tradizione militare svolgeva il ruolo aggregante che svolgeva invece nella società prussiana. Anche la rivoluzione ebbe nel Risorgimento un ruolo secondario.
I fattori fondamentali dell’unificazione italiana furono la cultura e la diplomazia. Fu, come si direbbe oggi, una “operazione di vertice” che, pur ricca di motivi civili, mirò a contenere i due fattori – il rivoluzionario e il militare – suscettibili di mobilitare le masse.
Fonte: G. Carocci, Storia d’Italia dal 1861 a oggi, Feltrinelli, Milano, 1975, pp. 13-19
Introduzione e redazione a cura di Luscino

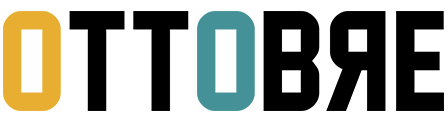







[…] quel racconto che analizza i punti salienti dello sviluppo del capitalismo in Italia. Dopo il primo capitolo circa le origini dello sviluppo del capitalismo nell’Italia pre-unitaria, passiamo con […]
[…] analizza i punti salienti dello sviluppo del capitalismo in Italia. Dopo i primi due capitoli sulle origini del capitalismo e sul suo sviluppo nel periodo dell’Italia liberale, ci affacciamo a quel periodo di massimo […]
[…] che ha abbracciato il primo secolo di storia del nostro paese sin dalla sua fondazione: dalle origini, all’Italia liberale, al regime fascista. In questo capitolo Carocci analizza con lucidità […]